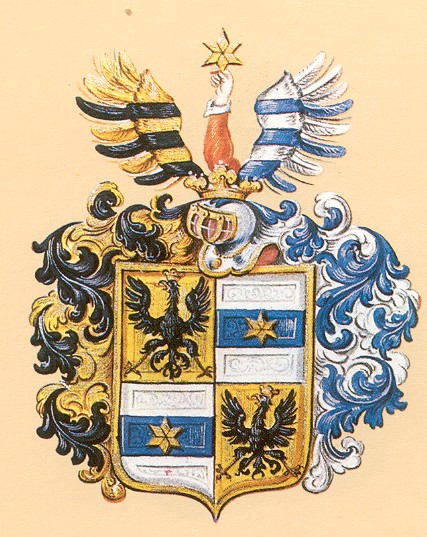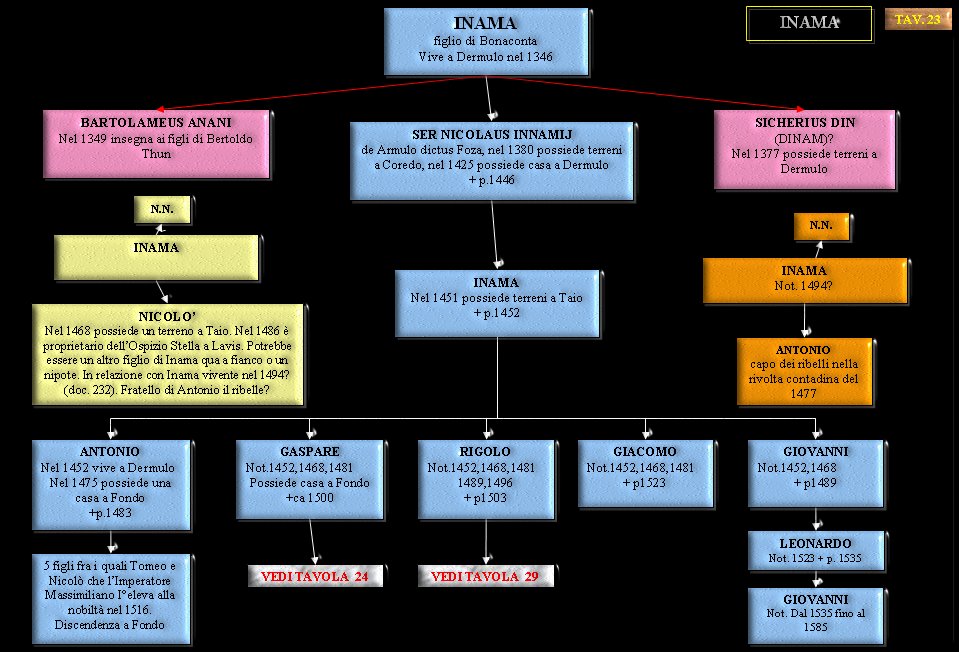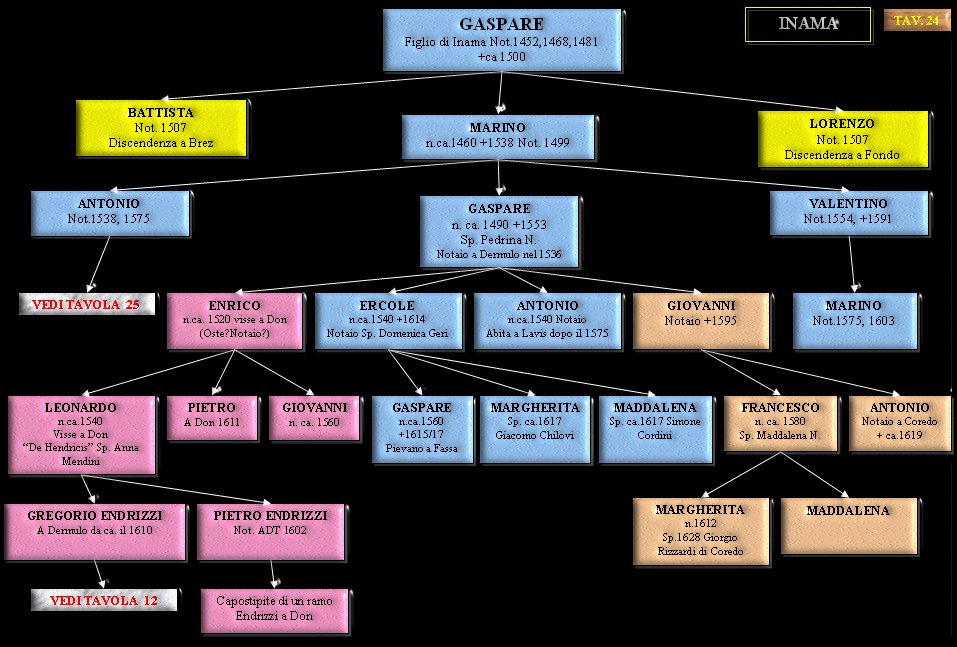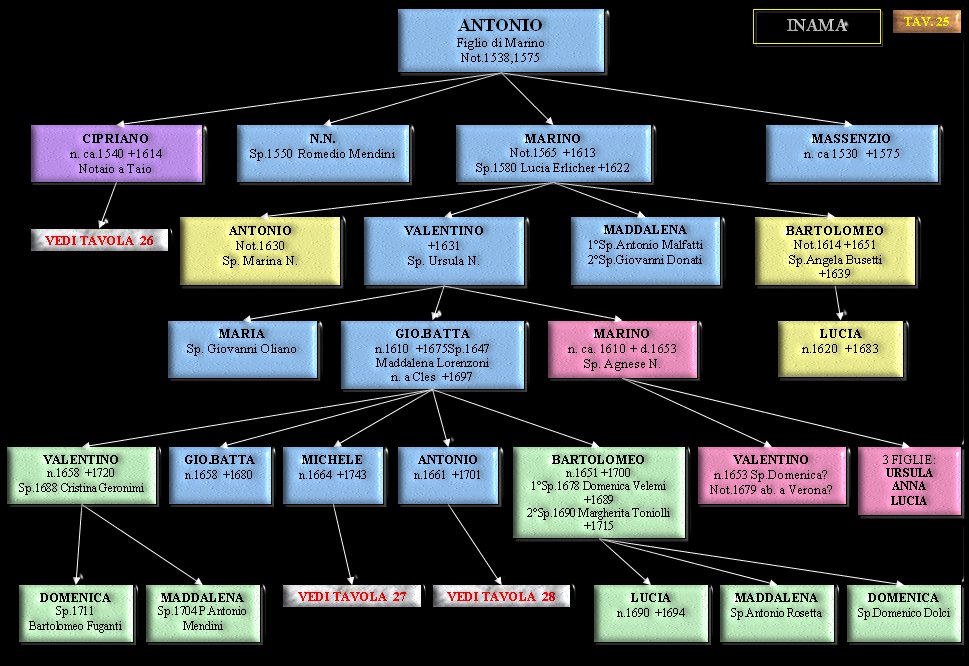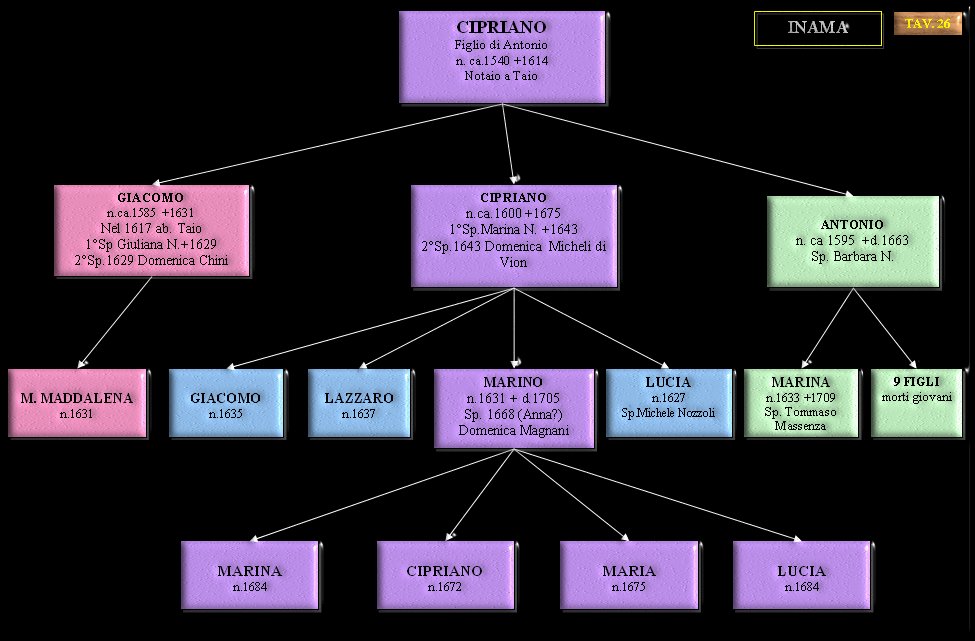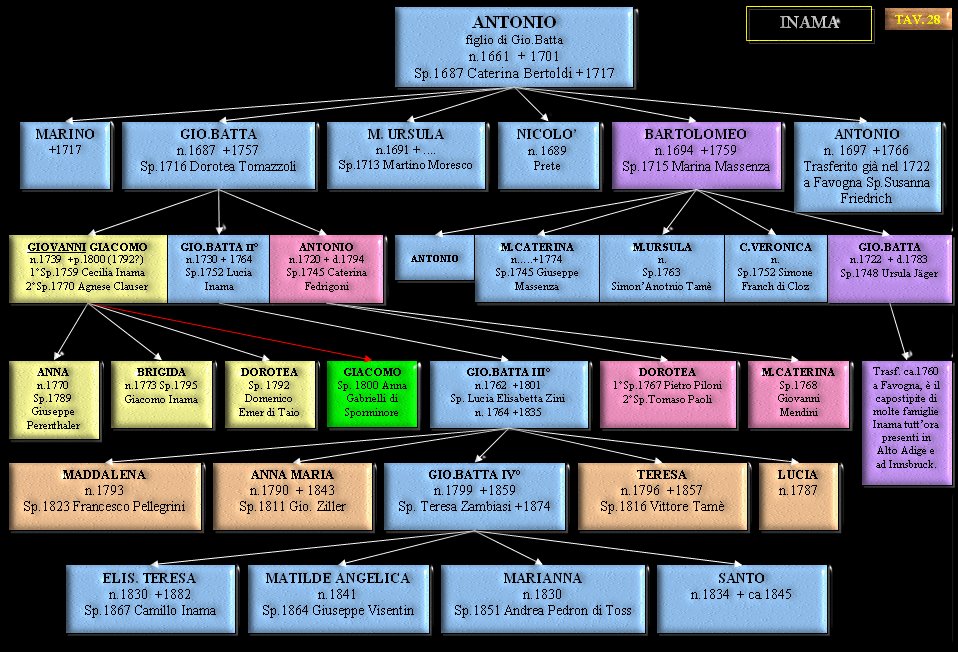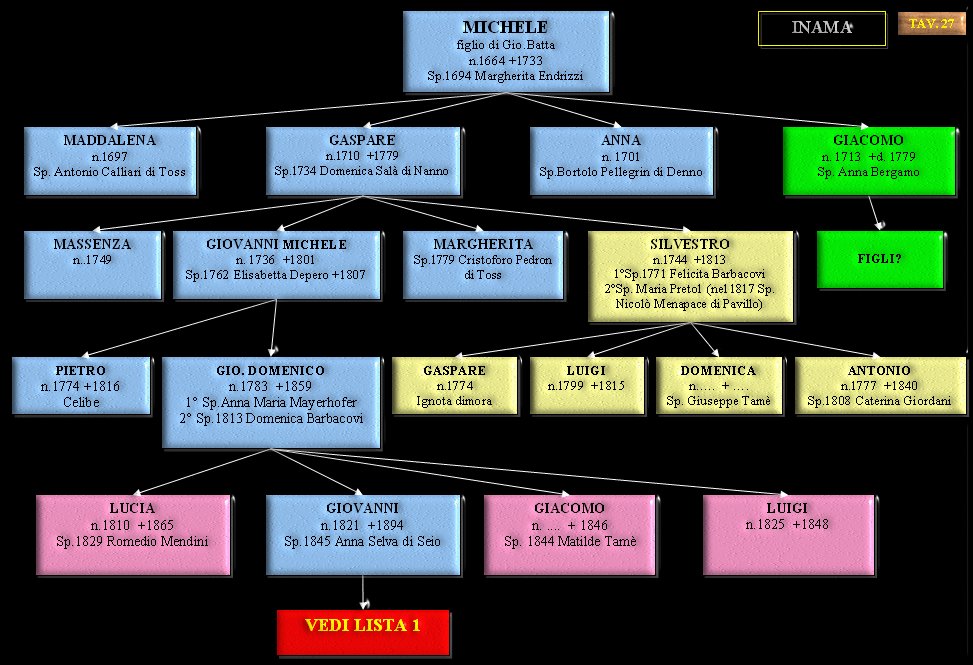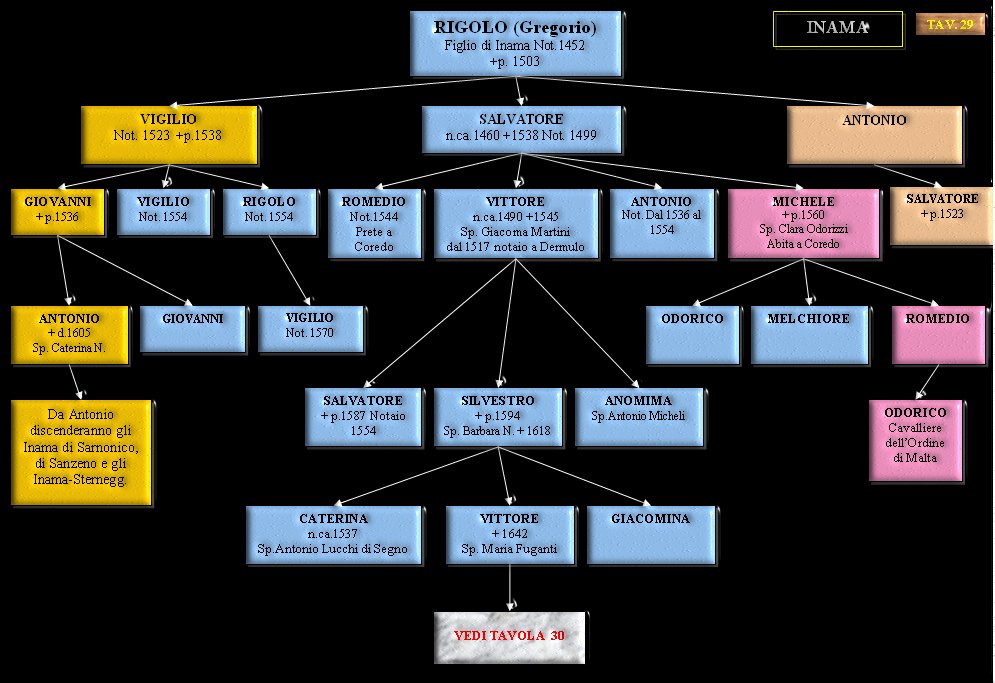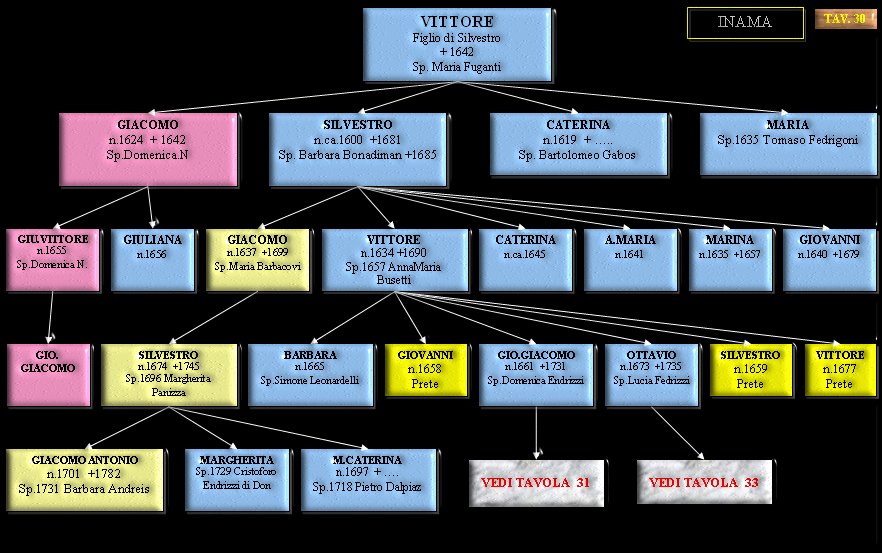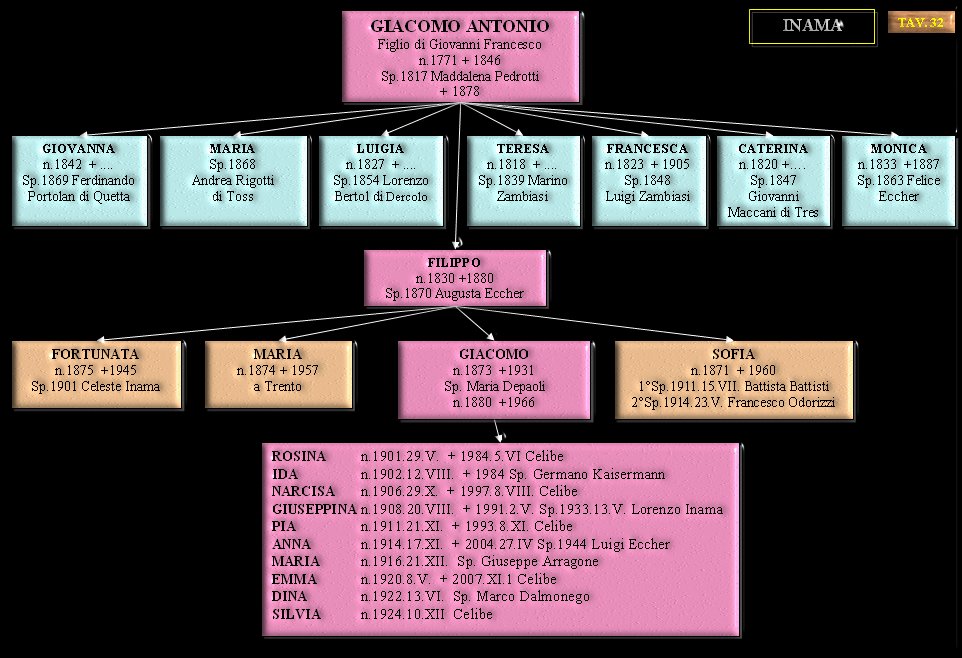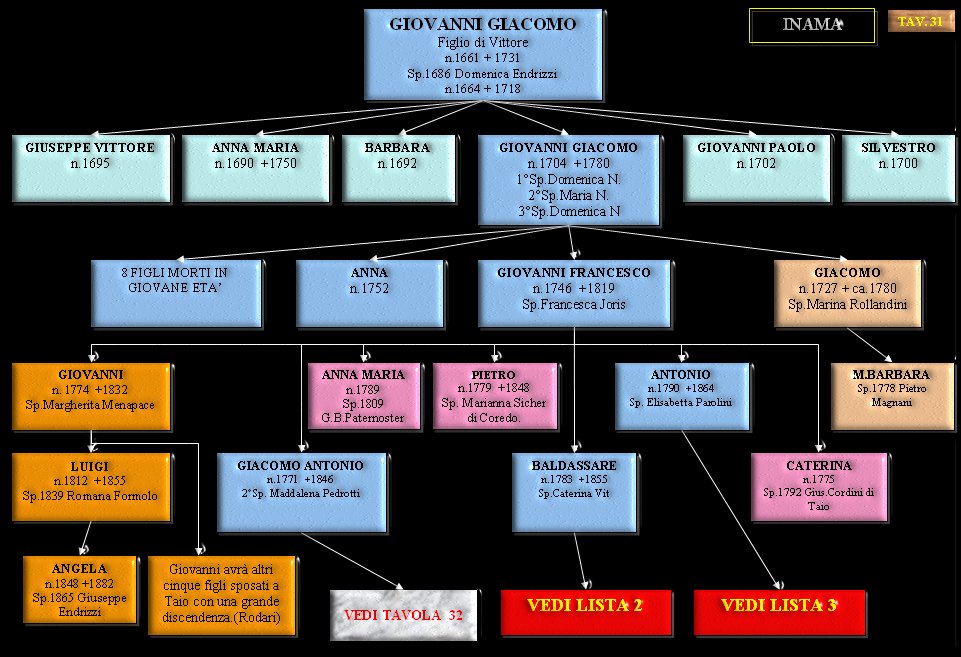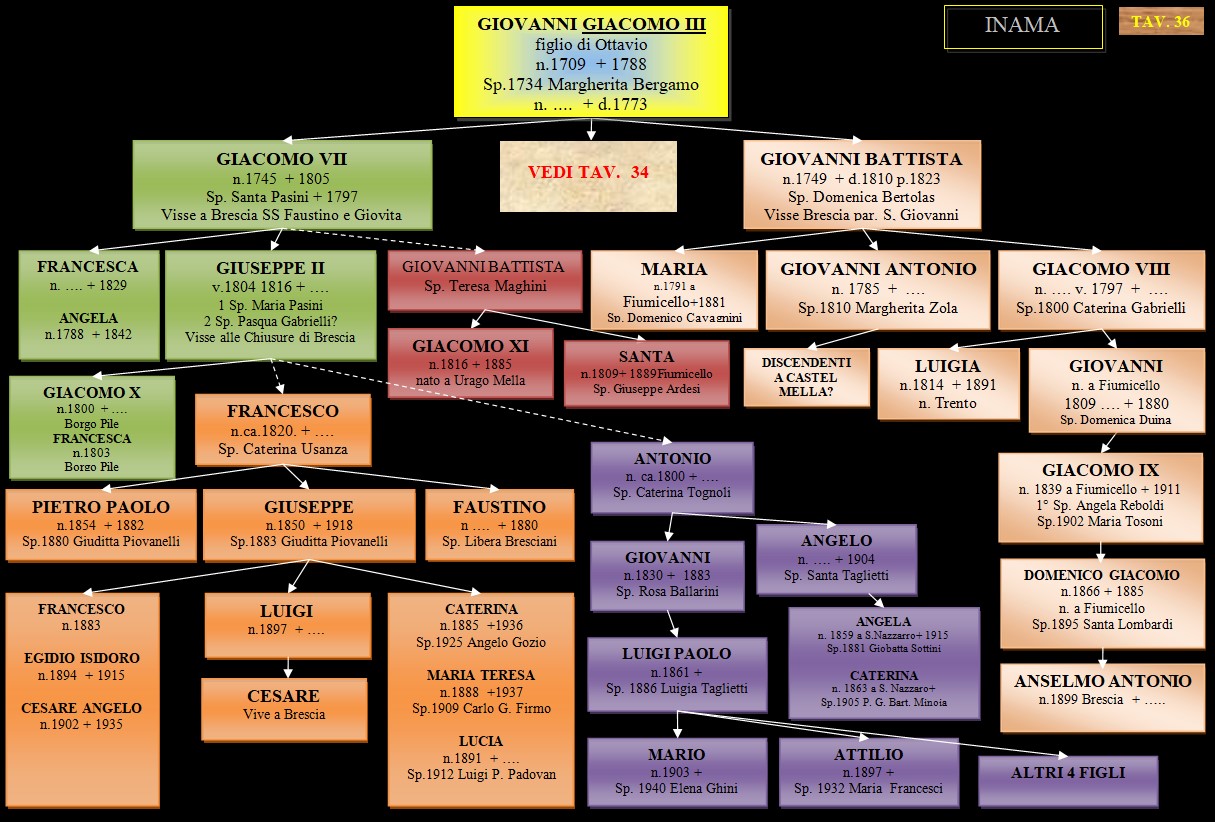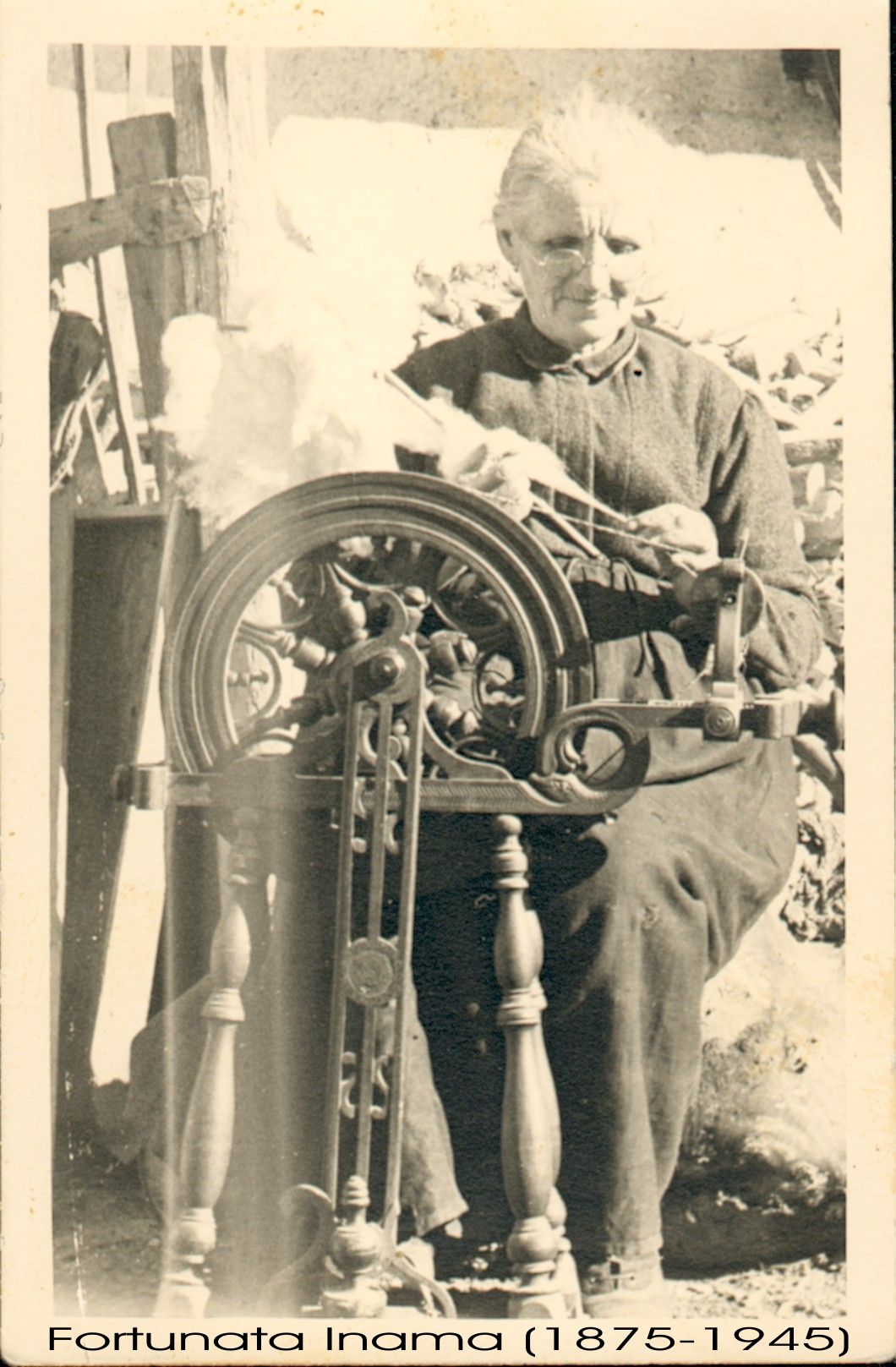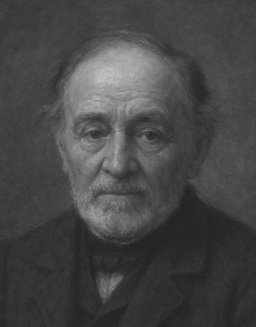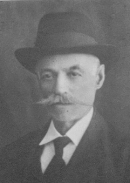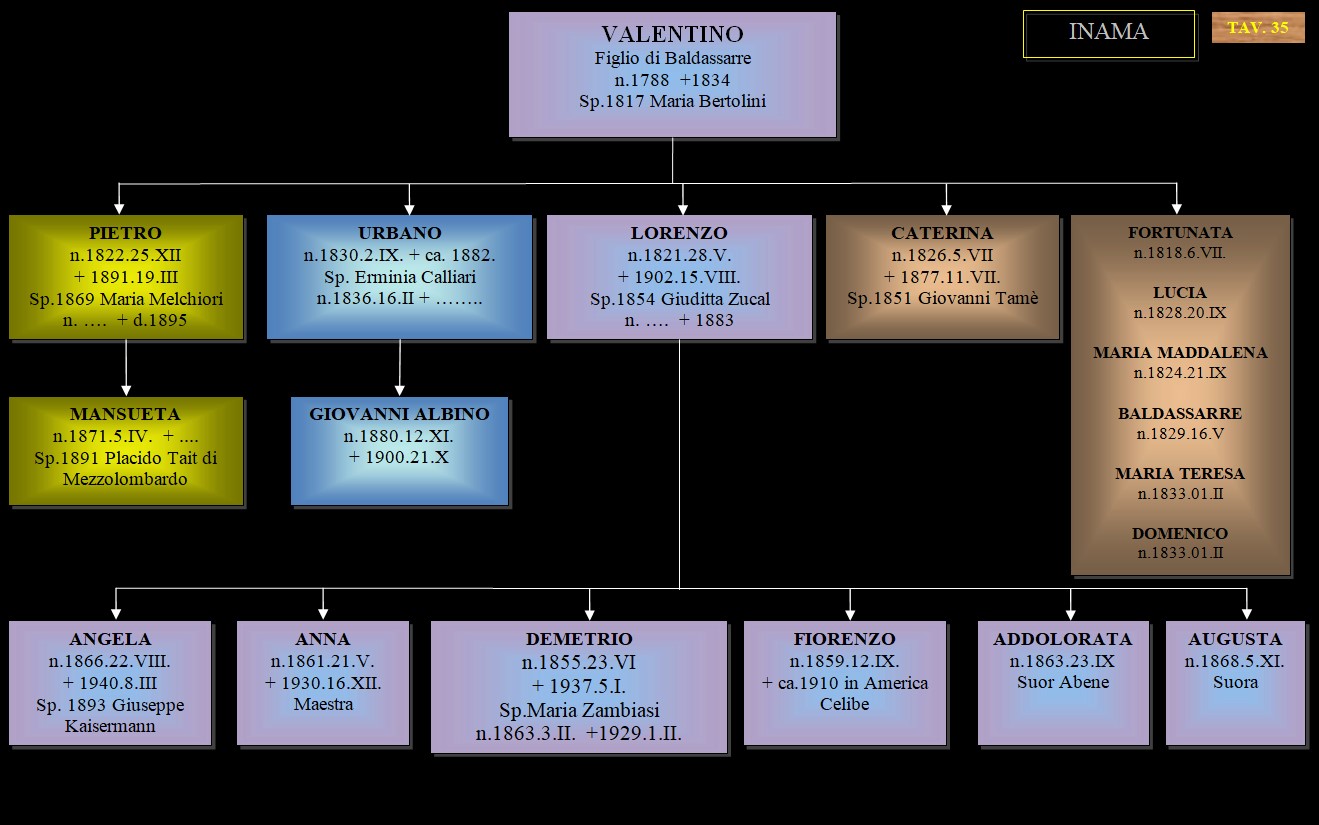LE FAMIGLIE INAMA
|
LA
LINEA DI GASPARE |
LA
LINEA DI GREGORIO |
|
DOCUMENTI |
DOCUMENTI |
|
LISTA 1 |
LISTA 2
LISTA 3
LISTA 4 |
| LISTA 5 LISTA 6 LISTA 7 LISTA 8 |
|
Il cognome Inama è fra più antichi di Dermulo dove è presente fin dalla metà del Trecento. Qualcuno fa derivare il nome
Inama da Denno, de Enanis cioè di Eno e d’Enno, e a conferma del
collegamento ci sarebbe anche la somiglianza fra lo stemma degli Inama,
quello degli Alberti d’Enno e anche quello dei signori della Corona di
Denno. Inoltre Carl Ausserer in “Der Adel des Nonsberges” dice: “Una
grande parte della popolazione di Dermulo porta il cognome Inama e da qui
gli Inama si sono sparsi in tutta la val di Non. Non c’è spiegazione per
questo cognome. La gente di Dermulo era nel secolo XII soggetta al
vassallaggio dei signori di Denno, ne venne però dispensata in seguito
all’assassinio dei conti Federico e Enrico di Appiano da parte dei figli di
Olurandino di Denno. Il 17 febbraio 1218 il vescovo Federico dichiara quelli
di Dermulo liberi e vassalli soltanto della chiesa di San Vigilio e il 9
settembre 1220 il loro privilegio viene confermato dal vescovo Adalpreto. Ma
nell’enumerazione di questa gente non si trova nessun nome che ricordi in
qualche modo quello degli Inama.” In effetti che il nome Inama
sia in relazione con Denno, è stato poi smentito dallo stesso Hanns Inama
Sternegg, che ha scoperto il capostipite Innama o Innamius figlio di un
Bonaconta, in un documento redatto a Dermulo nel 1343. Bonaconta dovrebbe
essere stato originario di Tres. (V. Tav. 23) Altre ipotesi, fanno derivare Inama da Benamatus, da cui Benamà, Enama e Inama, oppure dal contrario “Inamatus” non amato. Nel Medioevo si trova anche Innamus come nome proprio, anche se raramente. Alcuni Inama, lasciarono Dermulo in epoche diverse per raggiungere altri luoghi.[1] Già alla fine del Quattrocento sono a Fondo,[2] poi a Ronzone e Sarnonico,[3] e alla metà del Cinquecento prende origine un ceppo a Lavis.[4] Ai primi del Cinquecento Michele Inama figlio di Salvatore, prendeva in moglie una certa Clara Odorizzi di Coredo, e si trasferiva in quel paese.[5] Nel Seicento da Dermulo si trasferirà a Taio, Giacomo Inama che però estinguerà la discendenza alla fine del Settecento.[6] Alla metà del Settecento Gio.Batta Inama figlio di Bartolomeo di Dermulo si trasferirà a Favogna e darà origine ad una numerosa discendenza in Alto Adige.[7]
Oggi a Dermulo vivono i discendenti dei due fratelli Gaspare e Rigolo figli di Inama, descritti con le loro genealogie rispettivamente nei capitoli 1. e 2.[8] 1.LA LINEA DI GASPARE[9]
1.1. GASPARE FIGLIO DI INAMA I SUOI FIGLI E NIPOTI V. Tav. 24
Il signor Sigismondo di Thun il 3.12.1452 in Castelbrughier, con atto redatto dal notaio Michele nobile di Tavon, diede in feudo ad Antonioium quondam de Iname de Hermulo e ai suoi fratelli Gaspare, Rigolo, Giacomo e Giovanni un terreno alle streghe longhe situato nel territorio rurale di Dermulo. Con questo atto viene dimostrata la presenza storica di quell’Inama che è conosciuto con questo solo nome. Poiché Gaspare morì, in ogni caso molto vecchio, tra il 1499 e il 1507 si può far risalire la sua data di nascita tra il 1420 e il 1425. Nella successiva lettera di infeudamento del 1468 riguardante lo stesso terreno, come pure in cinque atti dello stesso anno ed inoltre in quelli degli anni 1469, 1472, 1475, 1484, 1489, 1496 e 1499 risulta a volte come testimone o proprietario della casa nella quale furono redatti gli atti stessi e a volte come venditore-compratore. Nel 1489 e nel 1496 vendette al cavaliere Simone di Thun un campo e un prato nel territorio rurale a Saregen di Taio per la somma di rispettivamente 50 e 25 marche meranesi insieme a suo fratello Rigolo e come tutore degli eredi del suo defunto fratello Giovanni, e come rappresentante di suo nipote di ser Nicolò di Fondo. Ad ogni modo dal 1468 Gaspare visse a Fondo in una casa che, probabilmente, possedeva in comproprietà con i suoi fratelli. Nulla si sa della moglie, ma sappiamo che ebbe tre figli di nome Marino, Battista e Lorenzo. I discendenti di Battista, vissero come piccoli proprietari a Brez e Rivo fino all’inizio del XIX secolo. Di Lorenzo, possiamo per ora dire solo che ufficialmente viene nominato una sola volta, nel 1507. Da lui discese quella linea de Lenzi di Fondo che si estinse nel 1770 circa, alla 5° generazione. Marino appare nei documenti il 29 giugno 1499 come sindico della gente di Dermulo, quando i rappresentanti dei villaggi della media Val di Non si presentarono riuniti davanti a Pangrazio Khuen di Belasi, vicario generale della valli di Non e di Sole, per richiedere al feudatario vescovile l’approvazione delle decisioni della dieta di Merano, in base alle quali la tassazione degli abitanti delle valli per la guerra con Venezia, doveva essere fatta solo in ragione del valore dei loro beni. Nell’anno 1505 o 1506, dopo la morte del padre, aveva ereditato la doppia casa di famiglia, oggi n. 2 e n. 3, a Dermulo che è ancora oggi in possesso della famiglia.[Si tratta delle case oggi di proprietà di Candido Inama, Alessandro Inama e Antonio Inama.] Nel 1538 era già morto. Nel 1549, quando Antonio del fu Salvatore, in qualità di più anziano degli Inama, riceve i feudi di Sigismondo di Thun, gli eredi quondam Marinus de Enamis risultano come compartecipi dei diritti. Marino lasciò almeno tre figli: Gaspare, Antonio e Valentino. Quest’ultimo viene nominato tra il 1554 e il 1591 soprattutto in contratti agrari dei confinanti e suo figlio Marino in analoghe scritture tra il 1575 e il 1603. Oltre a questo non possiamo dire altro sia del padre che del figlio.[10] Antonio, figlio del primo Marino, fondò con i suoi numerosi discendenti la linea che è arrivata fino ai nostri giorni. Gaspare sarà l’argomento del prossimo paragrafo.
1.1.1. GASPARE (+1553) FIGLIO DI MARINO
Gaspare, probabilmente il primogenito del primo Marino, fu notaio in Dermulo dal 1536. In questa qualità appare ufficialmente in molti atti dall’anno ricordato fino al 1553. Morì nel maggio 1553, non in tarda età. I documenti notarili stilati di sua mano riguardano atti delle famiglie Cordini, Chilovi, Torresani, Mendini, Rolandini, Barbacovi e altre, con le quali vi erano già molti rapporti di parentela e altri ne sarebbero stati stretti in seguito. Si tratta soprattutto di vendite di terreni. Nel 1549 era stato nominato giudice conciliatore nella disputa di famiglia dei Thun-Filippini. Dopo la sua morte il notaio Giovanni Giacomo Poletti, su richiesta della vedova Pedrina (di famiglia non conosciuta), assunse la tutela dei ragazzi minorenni, come pure il disbrigo degli atti notarili in essere. Il nominato Gaspare (+ 1553) ebbe quattro figli. Tutti ebbero discendenti. Il figlio Antonio si trasferì a Lavis in Val d’Adige nel 1575 circa, la linea che da lui discese si estinse nei primi anni del Settecento. [Antonio che era notaio, nel 1582 riscrisse la regola del piano della comunità di Coredo.[11] Un suo nipote di nome Giuseppe, pure notaio, possedeva ancora negli ultimi anni del Seicento una parte di casa n. 3 a Dermulo, parte che sarà poi ceduta ad Ottavio Inama]. Anche il figlio successivo, Enrico, lasciò la natia Dermulo per stabilirsi a Don. I suoi figli, Leonardo, Pietro e Giovanni abbandonarono il nome di famiglia Inama e dal nome del padre si chiamarono de Henricis, Antrigi o Andrigi. Leonardo e Pietro vissero a Don,[12] Giovanni dal 1600 circa a Termeno dove si fa chiamare Hanns Antrigi e si sposa con Benedikta Guetmorget. Rimane lo spazio per ulteriori ricerche per individuare eventuali discendenti. Il terzo figlio di Gaspare fu Ercole, anche egli notaio. Tra il 1563 fino al 1611, si occupò di documenti di una certa rilevanza locale. [Ercole morì nel 1614]. Sua moglie Domenica Geri di Casez gli diede almeno tre figli, ed esattamente due figlie (Maddalena, sposata nel 1617 circa con Simone Cordini e Margherita sposatasi nel 1617 circa con Giacomo Chilovi) e Gaspare, l’ultimo con questo nome. Questi nel 1593 studiò all’università di Dillingen, abbracciò la vita religiosa e dal 1602 fu parroco e decano in Val di Fassa. Morì tra il 1615 e il 1617. Nella sua vita aveva redatto molti atti che riguardavano proprietà a Termeno. Per questo si mise molte volte in contrapposizione con suo zio Antonio Inama, attuario del tribunale di Montereale come pure con il prevosto di San Michele. Il quarto figlio dell’ultimo Gaspare, Giovanni, morì già nel 1595; era notaio poiché era chiamato ser. Non si conosce il nome della moglie. Suo figlio Antonio gli sopravvisse solo fino al 1603.[Di Antonio, che era pure notaio, si trovano nell’archivio parrocchiale di Coredo, almeno 6 documenti da lui sottoscritti. Il periodo va dagli anni 1604 al 1610, quindi la data 1603 va spostata in avanti di almeno sette anni].[13] L’altro figlio, Francesco, nel 1600 era ancora minorenne e quindi fu necessario nominargli un tutore nella persona di Gabriele Barbi. Dopo aver raggiunto la maggiore età - così possiamo arguire - egli sposò Maddalena N. dalla quale ebbe due figlie ma, presumibilmente, nessun altro erede. Le figlie si chiamavano Maddalena e Margherita (nata nel 1612); quest’ultima andò sposa nel 1625, appena tredicenne, a Giorgio Rizzardi. [Giorgio e Margherita si sposarono il 21 gennaio 1628 e non 1625, quindi la sposa aveva 16 anni.[14] Nel 1670 era vedova e redigeva testamento ricordandosi anche della chiesa di S. Giacomo di Dermulo].[15]
1.1.2. ANTONIO (+1575) FIGLIO DI MARINO V. Tav. 25
La prima presenza ufficiale di Antonio, si ha come testimone nel 1538, quando suo padre era già morto. Nella stesso ruolo, come pure in quello di confinante di terreni, lo troviamo molte volte fino al 1575. Qualche volta si trattava di parenti delle famiglie Inama, Cordini, Mendini, ecc., qualche volta dei signori di Thun, qualche volta di persone i cui legami con Antonio non possono essere determinati con precisione. I beni da lui venduti si trovano per la maggior parte a Dermulo ma alcuni anche a Coredo, Rallo, Tassullo. Egli si trovava in difficoltà a pagare gli affitti arretrati ai signori di Thun, e quindi invece di pagamenti in denaro, cedeva loro dei terreni. Nel 1554 egli stima la casa dei figli del defunto notaio Vittore Inama che doveva essere messa in vendita, nel 1555 è creditore di una certa Anna de Pangratiis, nata Cordini, il cui marito Antonio de Pangratiis, insieme con il notaio Baldassarre Oliva (di Nano)[Nanno], era stato eletto l’anno precedente sindico di Dermulo. In questa elezione, su 18 aventi diritto, 9 si chiamavano Inama. Nel 1559 Antonio vendette un fondo nel territorio rurale delle streghe longhe di Dermulo a Floriano Inama di Fondo. Nel 1559 vendette a Cristoforo Inama di Fondo anche la sua parte di diritti del feudo di famiglia nella stessa località concesso dai Thun. Ma d’altra parte nel 1562 prese in affitto dai Thun nuovi terreni fino allora incolti e acquistò un terreno a Malosco. Nel 1570 prese parte a Fondo alle trattative riguardanti la regolamentazione delle sorgenti d’acqua che interessavano gli abitanti di Dermulo. Nel 1575 lo troviamo ufficialmente per l’ultima volta a Terzolas. Dal suo matrimonio con una donna che rimane sconosciuta, nacquero oltre a una figlia, di cui non si conosce il nome, che sposò Romedio Mendini e al figlio Massenzio (documenti ufficiali del 1565, già morto nel 1575), due altri figli: Marino e Cipriano. Il nome Massenzio, che nella famiglia non era mai stato usato, ci può far supporre che la madre provenisse dalla famiglia Massenza che si era già da tempo stabilita a Dermulo.
Cipriano, (V. Tav. 26) che appare per la prima volta ufficialmente nel 1591, era notaio. Viene chiamato ser e peritus. Rappresentò le comunità di Taio e Dermulo in una vertenza con Tres sull’obbligo di manutenzione dei ponti in Val di Non e di quello di Storio in Val di Sole e per i costi di una nuova campana per la chiesa parrocchiale di San Vittore a Taio. A quest’ultima parrocchia appartenevano tutti e tre i paesi appena nominati. Qui Cipriano aveva stabilito la sua residenza. Nel 1606 si definisce habitator villae Taij. Morì il 13 maggio 1614 [10 marzo?] e oltre a Giacomo, che si sposò due volte senza avere figli (la prima con Giuliana N., morta nel 1628 e la seconda con Domenica Chini), [Giacomo nel 1617 era sindaco della chiesa di Taio, e dalla seconda moglie Domenica risulta avere avuto una figlia di nome Maddalena, nata nel 1631] lasciò anche Cipriano II° e Antonio. Ambedue ebbero molti figli e Cipriano II° anche nipoti. [Marina figlia di Antonio nata nel 1636 andò in moglie a Tommaso Massenza. Marino figlio di Cipriano II°, sposatosi con Domenica Magnani nel 1668, risultava confinante di una parte di casa n. 2-3, nel 1695. Presumibilmente quindi si può affermare che in questa porzione di casa (a mattina) avessero abitato i suoi antenati. Di Cipriano II° oltre al succitato Marino, conosciamo altri figli: Giacomo, Antonio (+1635), Lucia e Lazzaro. Il nome proprio Lazzaro, che non era per tradizione usato nelle famiglie Inama, ci può far presupporre che forse Marina, moglie di Cipriano II°, fosse una figlia di Lazzaro Chilovi di Taio.] Non sembra però che ci siano stati altri discendenti poiché nel 1710 non risultava vivente più nessuno di questa famiglia.
Al contrario la famiglia di Marino, figlio di Antonio il vecchio, documentato ufficialmente dal 1565 al 1613,[anno in cui morì] si perpetua fino ai nostri giorni. [Marino aveva sposato nel 1580, Lucia figlia di Bartolomeo Erlicher di Coredo][16] In verità la discendenza sembra estinguersi con i nipoti di suo figlio Bartolomeo (morto nel 1651) che si era sposato con Angela Busetti,[a Bartolomeo, il cui nome riprendeva quello del nonno materno, sono attribuiti da Karl Inama due figli: Lucia e Marino. In un documento del 1646 risulta però che Marino era figlio del fu Valentino e non del fu Bartolomeo. Da un documento del 1679 apprendiamo poi dell’esistenza di Valentino figlio del fu Marino Inama abitante a Verona. Valentino era nato a Dermulo nel 1653.] ma nel Valentino morto il 15 dicembre 1631, e che era apparso ufficialmente nel 1591 (in occasione della vertenza riguardante i ponti ricordata sopra), potremmo riconoscere un fratello di Bartolomeo. [Bartolomeo era sindaco della chiesa nel 1617, quando Simone Cordini e Giacomo Chilovi, donarono a questa un terreno a Cambiel. Da un documento del 1646, stranamente risulta, che Bartolomeo era un fratello di Cipriano II° e quindi figlio di Cipriano senior, ma potrebbe essere un errore. Fratello di Valentino, era anche un Antonio che aveva sposato una certa Marina. Dal loro matrimonio nacque il 28 febbraio 1630, Lucia. In occasione di tale nascita Antonio è detto inequivocabilmente fu Marino.] Ma sarebbe anche possibile, che il Valentino che nel 1591 veniva indicato semplicemente come Valentinus Inama Hermuli, fosse un figlio del Marino documentato tra il 1573 e il 1603, che appare ufficialmente tra il 1540 e il 1591 e che nel 1603 era già morto. [Quest’ultima eventualità si è rivelata esatta, infatti se il Valentino citato nel 1591, fosse quello nato dal matrimonio celebrato nel 1580 fra Marino e Lucia Erlicher, la sua età sarebbe stata nella migliore delle ipotesi di 10 anni. Dopo aver osservato i dati in nostro possesso, si può affermare con certezza che il Valentino morto nel 1631, era figlio di Marino e Lucia Erlicher]. Giovanni Battista figlio di Valentino (1610-1675), sposato dal 1647 con Maddalena Lorenzoni di Cles, morta nel 1697, lasciò quattro figli con discendenza e uno di nome Gio.Batta rimasto celibe. Ma mentre le famiglie dei due figli Bartolomeo e Valentino si estinsero con i figli e i nipoti, [dai due matrimoni nacquero solo femmine] quelle dei figli Antonio (1661-1745) trattata nel paragrafo 1.1.2.1. e Michele (1664-1743) paragrafo 1.1.2.2. proseguirono. I matrimoni degli appartenenti a queste linee furono molto fecondi, ma nella maggior parte dei casi, solo uno dei figli portò avanti la discendenza. [Posso ipotizzare che la cosiddetta “casa al di là del rì” che non era una vecchia residenza Inama, sia stata acquistata proprio dal primo Giovanni Battista. I suoi figli Antonio e Michele acquisiranno poi le parti dagli eredi degli altri due fratelli Bartolomeo e Valentino. Bartolomeo nel 1678 si sposa una prima volta con Domenica Valemi di Taio dalla quale ha due figlie, Domenica e Maddalena che prenderanno marito rispettivamente Bartolomeo Fuganti di Taio e Pietro Antonio Mendini. Nel 1689 rimane vedovo e l’anno dopo si risposa con Margherita Toniolli di Romallo. Bartolomeo muore nel 1700. Valentino aveva sposato nel 1688 Cristina Geronimi[17] ma pure lui ebbe tre figlie, Lucia, Domenica e Maddalena. Domenica sposerà Domenico Dolci, e Maddalena, Antonio Rosetta di Taio.] Con il passare delle generazioni le condizioni economiche di queste linee si deteriorarono. Fu una vita molto modesta da contadini che permetteva alle famiglie molto numerose solo di provvedere a quanto strettamente necessario alla vita di tutti i giorni. Fino ai nostri giorni questa linea ha avuto il soprannome Foia o Foga di cui non ci è possibile spiegare il significato. Naturalmente si è tentati di pensare a una connessione con il soprannome Foza con il quale già nel 1400 era soprannominato Nicolò dictus Foza, antenato di tutti gli Inama viventi. [Il riscontro documentale del soprannome “Fogia” è però abbastanza recente, collocandosi circa a metà Ottocento. Prima infatti gli antenati degli attuali “Fogia” avevano altri soprannomi ad esempio “Salà” o “Dall’oglio”. In quanto al “Foza” si può osservare che a Tres era anche un cognome molto diffuso e ivi presente almeno dal Cinquecento. Considerando che Bonaconta, capostipite degli Inama, sembrava provenire da Tres, non è da escludere una parentela in antico fra gli Inama e i Fozza].
1.1.2.1. ANTONIO FIGLIO DI GIO.BATTA E LA SUA DISCENDENZA V. Tav. 28
Antonio, nato nel 1661, era sposato dal 1687 con Caterina Bertoldi di Taio. Dal matrimonio si è a conoscenza della nascita di cinque figli maschi: Marino, Nicolò, Gio.Batta, Bartolomeo ed Antonio Junior ed una femmina di nome Maria Ursula. Quest’ultima andrà in moglie a Martino Morizzo di Sporminore. Di Marino si sa solo che è morto adolescente nel 1717. Anche di Nicolò nato nel 1689, si hanno poche notizie: intraprenderà la carriera ecclesiastica e nel 1744 sarà parroco a Taio. Antonio Junior nato nel 1687, lascerà Dermulo ed abiterà a Favogna già nel 1722,[18] dove aveva sposato Susanna Friedrich. Antonio lascerà a Favogna una numerosa discendenza che però si estinguerà ai primi anni dell’Ottocento. A Dermulo abiteranno quindi, con le rispettive famiglie, gli altri due figli di Antonio Senior: Gio.Batta e Bartolomeo. Bartolomeo detto Tomelin nato nel 1694, sposa Marina Massenza figlia di Gio.Batta, ed abita nella casa ai Massenzi proprietà della moglie. Dal matrimonio nascono almeno quattro figli, fra i quali due maschi di nome Antonio e Gio.Batta. Del primo non si hanno più notizie, è menzionato solamente una volta nel 1747. Il secondo, nato nel 1722, si sposa nel 1748 con Ursula Jäger e circa dal 1762 abita a Favogna.[19] Gio.Batta era muraro e lo si ritrova in molti atti come venditore di terreni, nel 1762 è rappresentato, siccome assente dalla patria, da Ignazio Manfroni suo curatore. Si trattava della vendita di un prato a Dermulo nella località al Ri. Dopo questa data, Gio.Batta lo si riscontra solo una volta, quando nel 1772, vendeva a Romedio figlio di Antonio Chilovi di Taio, la sua casa al Castiel, due campi a Cavauden e un prato al Ri. In tale frangente si dice che Gio.Batta abitava a Favogna. Le famiglie Inama di Laives, alcune di Bolzano e di Innsbruck, discendono proprio da Gio.Batta. Due figlie di Bartolomeo: Maria Caterina Veronica e Maria Ursula, si sposeranno a Dermulo rispettivamente con Giuseppe Massenza e Simone Antonio Tamè. Un’altra figlia di nome Caterina Veronica sposerà nel 1752 Simone Franch di Cloz.
1.1.2.1.1. LA DISCENDENZA DI GIO.BATTA FIGLIO DI ANTONIO SENIOR
Da Giovanni Battista, nato nel 1687 e morto nel 1757, prenderà origine il ceppo di famiglie Inama soprannominate Battistei, estintosi a Dermulo nell’ultimo ventennio dell’Ottocento con Elisabetta Teresa, figlia dell’ultimo Gio.Batta. Gio.Batta, che dovrebbe essere stato il figlio maggiore di Antonio, un po’ alla volta acquista le parti della casa al di là del ri, dai suoi fratelli: nel 1722 compera la parte del fratello Antonio già abitante a Favogna e nel 1747 quella di Bartolomeo per 105 Ràgnesi. Nel 1717, e sicuramente dal 1737 al 1747, Gio.Batta abita al maso Betta dov’era manente. E’ molto probabile comunque, che Gio.Batta sia rimasto nel maso come affitalino per quasi tutta la sua vita.[20] Del matrimonio di Gio.Batta con Dorotea Tomazzoli di Dres, si è a conoscenza della nascita di tre figli maschi: Gio.Batta II°, Giovanni e Antonio. Di tutti e tre non conosco la data di nascita (circa tra il 1720 e il 1730)[21], e nemmeno esattamente quella di morte; quest’ultima però è stata approssimata tenendo conto di quanto emerso da vari documenti, e quindi fissando la morte di Giovanni prima del 1800, quella di Gio.Batta II° nel 1764 e quella di Antonio dopo il 1794 non si è molto lontani dal vero[22]. Giovanni e Gio.Batta II°, sposano rispettivamente le due sorelle Cecilia e Lucia Inama, uniche figlie di Vittore Inama fu Ottavio. a) Giovanni avrà tre figlie: Anna, Brigida e Dorotea. La prima che era mammana,[23] si sposerà con il pintaio Giuseppe Perenthaler di Ghirlano. Inizialmente abiteranno a Dermulo, poi si sposteranno a Taio. Brigida sposa Giacomo Inama detto Sèp, e Dorotea, Domenico Emer di Taio.[24] Giovanni, che abitava nella parte di casa alla Crosara che fu del suocero Vittore Inama, alla sua morte lasciò diversi debiti che le figlie dovettero sanare con la vendita di alcuni terreni. Ricordiamo la curiosa situazione che si era creata nel 1819 fra Dorotea e i sindaci della Primissarìa. I rappresentanti di quest’ultima, reclamavano il mancato pagamento di alcuni oneri insistenti sui terreni del defunto Giovanni. Ne nacque una lite che si protrasse alcuni anni e della quale non conosciamo l’esito finale. b) Gio.Batta II° sposa nel 1752 Lucia Inama figlia di Vittore abitante a Taio. Egli morirà nel 1764,[25] lasciando un figlio di nome Gio.Batta (il III°), nato nel 1762. Gio.Batta III° poi sposandosi con Lucia Elisabetta Zini, avrà almeno cinque figli tra cui quattro femmine: Lucia, Anna Maria, Maddalena e Teresa. Anna Maria e Maddalena sposeranno rispettivamente Giovanni Ziller e Francesco Pellegrini entrambi di Sanzeno. Teresa sposerà nel 1816 con Vittore figlio di Giovanni Maria Tamè di Dermulo. L’unico figlio maschio, manco a dirlo, si chiamava Gio.Batta (il IV°) detto Betin e con lui, essendo nate dal suo matrimonio con Teresa Zambiasi solo femmine, si estinguerà il ceppo dei cosiddetti Batistei.[26] L’ultimo Gio.Batta, svolse per diversi anni (fra il 1820 e il 1847) la mansione di guardaboschi, su incarico del Comune di Dermulo. Nel 1837, Teresa moglie di Gio.Batta IV°, cede a Romedio Mendini tutta la vecchia casa Inama misurante una superficie di 114 Pertiche. Romedio gli assegna in cambio i terreni che qualche anno prima aveva ereditato dallo zio. Una figlia di Gio.Batta IV°, di nome Teresa Elisabetta, sposerà Camillo Inama figlio di Giacomo. I Batistei abitavano tutti nella casa paterna n. 13-14. c) Antonio detto Possident il terzo figlio di Gio.Batta I°, aveva sposato nel 1745 Caterina Fedrigoni di Rumo. Le sue due figlie Dorotea e Maria Caterina andranno in mogli rispettivamente a Pietro Piloni di Cles e a Giovanni Mendini di Dermulo. Doretea rimasta vedova, si risposa con Tommaso Paoli di Nanno che abitarà per un certo periodo a Dermulo. Giovanni Mendini, abiterà nella parte di casa n. 13-14 proprietà della moglie e del suocero, del quale sarà rappresentante nei molti affari di permute, vendite od altro che lo vedevano protagonista. In una disputa, per il luogo di costruzione di una nuova fontana, di Giovanni Mendini, si dice che è sotto la tutela del suocero Antonio Inama.
1.1.2.2. MICHELE FIGLIO DI GIO.BATTA E LA SUA DISCENDENZA V. Tav. 27
Michele nato nel 1664, sposa all’età di trent’anni Margherita Endrizzi figlia di Gregorio di Dermulo. Nel 1693 Michele compera, per 100 Ràgnesi da Antonio fu Giacomo Mendini, una parte di casa nello stesso colomello dove si trovava la casa eremitale e quella dei nobili Inama di Fondo. Nello stesso anno, vende per 70 Ràgnesi la sua parte di casa detta la casa Inama (la casa al di là del ri) al fratello Antonio. Degli almeno cinque figli nati dal matrimonio, due femmine di nome Maddalena (n.1697) ed Anna (n.1701) sposarono rispettivamente Antonio Calliari di Toss e Bortolo Pellegrin di Denno; due maschi di nome Gaspare (1710-1779) e Giacomo (1713-d.1779)[27], abitavano a Dermulo nella casa paterna ed erano entrambi sposati. Giacomo, si trova spesso citato negli atti notarili come compratore o venditore di beni. Nel 1753 vende al fratello Gaspare “una pergola alle Marzole” per 18 Ràgnesi; nel 1771 trasferisce agli eredi di Gio.Batta Inama due parti di casa alla Crosara; nel 1775 vende a Giovanni Mendini vari fondi e cioè: “al Fossà, alle Bertuse, al Ri, a S. Giustina, un canevaro alle Fontanele, a Cavauden e a Rizzol”. Nel 1742, Giacomo possiede in affitto i beni dei notai Guelmi, fra cui la casa (più tardi n. 1) e proprio in quell’anno si trova in difficoltà con il pagamento degli affitti e perciò gli sono pignorati il fieno, il frumento ecc. Giacomo era sposato dal 1736 con Anna Maria Bergamo di Portolo, ma non sembra aver avuto discendenza.[28] Gaspare nel 1734, aveva preso in moglie Domenica, figlia di Romedio Salà di Nanno. Da quanto si evince dai documenti reperiti, Gaspare sembra meno attivo del fratello nel campo delle compravendite. Però sarà protagonista di due importanti acquisizioni di porzioni di casa, confinanti da nord con quella paterna e che ancora oggi i suoi discendenti possiedono. Infatti, nel 1741 e nel 1766 acquista rispettivamente per 90 Ràgnesi una parte di casa dall’eremita Giacomo Fuganti, e un’altra parte dalla chiesa di Dermulo. Gaspare aveva avuto due figli, Giovanni Michele e Silvestro. Silvestro (1744-1813) detto Salà, si sposa due volte, la prima nel 1771 con Felicita Barbacovi, la seconda con Maria Pretol di Rumo. Nel 1817, quest’ultima rimasta vedova, sposa Luigi Menapace detto Kramer di Pavillo. Dai due matrimoni, nascono almeno dieci figli, molti dei quali morti in giovane età. Di quelli che arrivarono all’età adulta, ricordiamo Gaspare nato nel 1744 e partito da Dermulo senza dare più notizie, Luigi morto nel 1815, Domenica che sposerà Giuseppe Tamè e Antonio.[29] Antonio era sposato con Caterina Giordani di Nanno, ma non ebbe discendenti e alla sua morte, avvenuta nel 1840, furono designati eredi i figli di suo cugino Giovanni Domenico Inama. Quindi Giacomo, Luigi e Giovanni, divennero proprietari della casa n. 18, dei vari terreni e anche di un capitale di 59 fiorini e 50 carantani, prestato nel 1836 da Antonio al comune, per far fronte alle spese del colera. Da una lista del 1836 trovata nell’A.C.D., dove sono elencati i capifamiglia di Dermulo, Antonio è l’unico a far figurare una persona nella colonna riservata alla servitù.[30] Caterina morì l’anno dopo del marito, lasciando un’eredità stimata 96 fiorini in denaro e mobili. Detta eredità, passerà dai suoi eredi, a Romedio Emer.[31] Giovanni Michele, (1736-1801) sposa nel 1762 Elisabetta Depero di Toss, avrà diversi figli fra i quali Giovanni Domenico e Pietro. La discendenza proseguirà solo con il primo, giacché i figli di Pietro moriranno ancora bambini.[32] Giovanni Domenico (1783-1859) proprietario della casa n. 17-18 si era sposato due volte, l’ultima con Domenica Barbacovi. Fra la numerosa figliolanza solo Giovanni (1821-1894) porterà avanti la discendenza; fra gli altri figli ricordiamo Giacomo che si era sposato con Matilde Tamè nel 1844 ed era già morto nel 1846; Luigi morto celibe nel 1848 e Lucia che andrà in moglie a Romedio Mendini. Giacomo nel suo testamento del 25 marzo 1846, lasciò la sua sostanza al fratello Giovanni e un legato ciascuno alla primissaria ed al comune. In particolare alla primissaria lasciò 25 fiorini abusivi, con l’obbligo di una messa annuale perpetua. Dai due figli di Giovanni, che era sposato con Anna figlia di Tommaso Selva di Seio, Ernesto (1850-1914) e Daniele (1853-1926) trarranno origine i due ceppi delle famiglie Inama con soprannome Fogia[33] che ancora oggi abitano a Dermulo. (V. Lista n. 1). La figlia Emilia invece, prenderà marito nella persona di Geremia Inama figlio di Giuseppe.
2. LA LINEA DI GREGORIO (Rigolo)[34]
2.1. DA GREGORIO FINO A VITTORE (1631-1690) V. Tav. 29
2.1.1. GREGORIO FIGLIO DI INAMA E I SUOI FIGLI
Il nome di battesimo Rigolo, Grigolo, è da intendere come diminutivo di Enrico.[Secondo me invece, è una forma dialettale di Gregorio: Rigòl e quindi Rigòlo][35]. I componenti della famiglia con questo nome sono sempre indicati con questa forma locale e così noi dobbiamo accettare una certa autonomia del nome. Il nome appare di rado; poiché nella famiglia degli Inama prima non era mai stato usato e che nessun patrono portava questo nome, si potrebbe arguire che provenisse dalla famiglia della madre, che ci è rimasta ignota. Rigolo viene nominato per la prima volta nel documento di infeudatura dei Thun del 1452 e 1468; successivamente in molti atti fino al 1496; nel 1503 era indicato come già deceduto. In tutti gli atti appariva insieme con i suoi fratelli e nipoti. Ma mentre i fratelli Antonio e Gaspare avevano trasferito la loro residenza a Fondo già prima del 1468, Rigolo rimase a Dermulo e, senza dubbio, si occupò dei terreni ereditati. Rigolo è il capostipite della maggior parte delle linee con il cognome Inama ancora esistenti. Il capitolo che viene dedicato alla sua discendenza è quindi anche il più corposo; esso comprende la maggior parte delle famiglie che ancora oggi vivono a Dermulo e tutte quelle che vivono a Taio, Sanzeno, Sarnonico e le famiglie Inama von Sternegg e Inama von Sternfeld e altre. Il 4 marzo 1489 Rigolo e suo fratello Gaspare vendettero per sé e per i propri eredi come pure per i minori tutelati, figli del fratello Giovanni e come rappresentanti di ser Nicolò, di suo nipote e dei suoi fratelli, un terreno a saregen nel territorio di Taio a Simone di Thun, cavaliere, per 50 marche meranesi. Il 20 gennaio 1496 Rigolo e Gaspare figli del quondam ser Iname de Hermulo per sé e per gli eredi di Joannes loro fratello e per i propri eredi e Petrus Ename figlio del quondam ser Antonius Ename de Hermulo per la sua quarta parte vendono allo stesso Simone di Thun un comodo prato nello stesso territorio di Taio per 25 marche meranesi. L’atto di vendita fu redatto dal notaio Nicolò Inama di Fondo che appose il suo sigillo notarile. Questo si compone di una stella a otto punte. Non sappiamo nulla della moglie di Rigolo. Conosciamo tre figli, Salvatore, Antonio, Vigilio nati tra il 1455 e il 1465 circa. Nel 1510 Antonio era già morto; lasciò un figlio Salvatore che nel 1523 era morto e tutto fa supporre che non abbia lasciato discendenti. Anche Vigilio, ultimo figlio di Rigolo, ebbe cinque figli; fu nominato titolare del feudo dai Valèr; ma della sua vita non possiamo dire molto di più del fatto che nel 1523 possedeva un terreno alle streghe longhe di Dermulo confinante con il terreno infeudato. La sua data di nascita è da porre nel 1465 circa, nel 1538 era documentato come morto. Sua moglie, che ci è totalmente sconosciuta, ebbe almeno cinque figli. Questi furono: a) Fausto che si diede alla vita religiosa e fu parroco a Coredo. I locali registri battesimali lo nominano ancora due volte nel 1570 come padrino anche se in Coredo nell’ Anaunia memorie storiche p. 193 di Endrici la sua morte viene posta nel 1546. I figli b) Antonio, nato nel 1490 circa e c) Vigilio, nato nel 1500 circa sono dal 1536 nominati molte volte come testimoni in atti notarili e come venditori di terreni ai signori di Thun (1550, 1552, 1563). Non è noto se fossero sposati o se abbiano lasciato dei figli. Ma è interessante notare che, come risulta dal contratto di vendita del 1552, i tre fratelli (Antonio, Vigilio e Rigolo) si trovavano in comunione di beni con i figli del defunto Cristoforo de Coradinis di Dermulo. Qui si può supporre una parentela e cioè che la madre dei tre fratelli fosse una Cordini. Dobbiamo nominare ancora il quarto e il quinto figlio di Vigilio quondam Rigolus: d) Giovanni, nato nel 1495 circa e e) Rigolo, nato nel 1500 circa. Ambedue fondarono famiglie.
2.1.2. SALVATORE FIGLIO DI GREGORIO
Ser Salvatore rappresentò la comunità di Dermulo quando nel 1503 si discusse della costruzione di un campanile per la chiesa paesana di S. Maria.[36] Come accennato sopra, nel 1515 fu investito del feudo thuniano come più anziano della famiglia ma nel 1523 cedette lo stesso a Nicolò Inama, cugino di Fondo. Nel 1534 era ricordato come defunto. Ebbe quattro figli: Antonio, Vittore, Romedio e Michele. Di Vittore nato circa nel 1490 parleremo al n. 2.1.3. Nel 1538 il figlio maggiore Antonio comprò con suo fratello Michele un terreno a Dermulo appartenente ai figli minorenni del suo defunto cugino Giovanni. Per Antonio e Michele questa è la prima notizia storica. Quando Michele si trasferì a Coredo, Antonio gli vendette nel 1544 un terreno pianeggiante nel territorio alle palissole e nel 1545 concordò con lui un compromesso per la divisione dei loro beni. Nel 1540 Antonio ricevette il terreno infeudato dai Thun. Fino al 1554 Antonio appare spesso in documenti ufficiali, soprattutto con parenti della linea Inama ma anche in relazione alle famiglie imparentate Martini e de Pretis [Pret] oppure in atti comunali. Ci è completamente sconosciuta la moglie di Antonio; conosciamo un solo figlio Giovanni i cui riferimenti ufficiali si collocano tra il 1569 e il 1579. Era chiamato ser non sappiamo se fosse sposato; ad ogni modo non lasciò figli; quando morì nel 1584 nominò erede universale un certo Caldana. Il secondo figlio del vecchio (e primo) Salvatore (già morto nel 1534) fu Romedio che nel 1547 fu nominato monaco del chiostro sui monti di Sfruz, Smarano e Coredo e di Castel Brughier dove si occupò dell’impianto e della tenuta dell’archivio.[37] Può essere morto tra il 1550 e il 1560. L’ultimo ancora da nominare dei quattro figli di Salvatore il vecchio, è Michele. La possibile data di nascita è il 1500 e fu notaio a Coredo dove si stabilì senz’altro in seguito al matrimonio con Clara Odorizzi. Michele fu il capostipite della più vecchia linea delle famiglie Inama a Coredo che ebbe membri importanti ma che si estinse dopo poco tempo.[38]
2.1.3. VITTORE FIGLIO DI SALVATORE ED I SUOI FIGLI
Vittore lo incontriamo già nel 1517 come notaio attivo a Dermulo e quindi possiamo porre la sua data di nascita nel 1490. Oltre ai propri atti con i fratelli egli redasse e legalizzò molti atti legali in Castel Brughier e Castel Valèr. Negli atti del notaio Gottardo de Gottardis di Cles[39] appare spesso la vedova di Vittore, Giacoma, una figlia di Silvestro Martini di Revò, la prima volta nel 1551 quando Salvatore figlio maggiore di Vittore era già maggiorenne mentre gli altri fratelli, che non vengono nominati, erano ancora minorenni. Nel 1553 Giacoma richiese al notaio de Gottardis l’autorizzazione alla cessione di una delle case[40] dei figli a Dermulo ad Anna de Pangratiis, figlia del defunto Pietro de Cordini. Con il ricavato dovevano essere pagati dei debiti del defunto Vittore. Per l’alto valore della casa, Anna de Pangratiis dovette pagare 25 Ràgnesi e cedere 4 terreni. Conosciamo tre figli di Giacoma e Vittore. Oltre a una figlia, che sposò Antonio Micheli di Revò (morto nel 1571) ci sono Salvatore e Silvestro. Salvatore, nato nel 1520 circa, fu notaio subito dopo il padre; era attivo come tale in Castel Brughier già dal luglio 1545. Le menzioni ufficiali che lo riguardano comprendono 28 numeri nella raccolta di regesti delle storie delle famiglie. Morì tra il 1575 e il 1587, probabilmente poco prima di quest’ultima data. Oltre ai soliti atti di acquisto e vendita di terreni, di tutore nelle famiglie Chilovi, Torresani, Cordini, Mendini, Barbacovi, Arnoldi, Rolandini, ecc., una gran parte della sua attività si esplica nella trattazione degli affari della propria famiglia. Egli stesso fu nominato tutore dei figli dopo la morte di suo cognato Antonio Micheli avvenuta nel 1571. Non sappiamo se Salvatore fosse sposato. Non risulta che abbia avuto dei figli. Al contrario Silvestro, che alla morte del padre era ancora minorenne, può essere attestato solo attraverso due documenti del 1571 e 1572. Possiamo presumere che con la moglie, una certa Barbara N., vivesse nella casa avita di Dermulo del suo antenato Rigolo sita al n.[ex] 26/27 che era chiamata casa Inama di sotto alla Crosara, e che è ancora oggi esistente.[Barbara morì nel 1618]. E’ provato che questa casa nel 1681 era di proprietà di un nipote di Silvestro, che aveva lo stesso nome (1600-1681). Silvestro, il primo con questo nome (ripreso dal nonno materno Martini), e Barbara ebbero due figlie che si sposarono a Dermulo il 29 aprile 1597 (con questa data iniziano le iscrizioni nei registri parrocchiali della competente parrocchia di Taio)[41], e un figlio Vittore che proseguì la discendenza e fu il capostipite di numerose famiglie Inama che ancora oggi esistono sia a Dermulo che in altri paesi.
2.1.4. VITTORE (ca.1570-1641) FIGLIO DI SILVESTRO ED I SUOI FIGLI V. Tav.30
Vittore, nato nel 1570, può essere identificato ufficialmente solo due volte, nel 1603 e nel 1608. Nei documenti che riguardano suo figlio Silvestro, Vittore è definito più volte magnificus dominus ma non ser. Sembra che questa denominazione onorifica, indichi più un innalzamento della posizione sociale, piuttosto che il fatto che fosse notaio. Sembra che abbia abitato e restaurato la casa del padre a Dermulo; prima del suo abbattimento, sull’arco del portone che immetteva nel cortile si poteva leggere la data 1627.[42] Vittore si sposò al suo paese il 28 maggio 1597 con Maria Fuganti che gli diede almeno cinque figli; conosciamo le date di nascita solo di Caterina, nata nel 1619 e sposata nel 1642 con Bartolomeo Gabot [Gabos?] e del figlio più giovane Giacomo nato il 5 gennaio 1624. Il figlio maggiore Silvestro può essere nato intorno al 1600, lo seguirono due sorelle: Marina e Maria; la prima morì nubile nel 1657 mentre la seconda era sposata con Tomaso Fedrigon dal 1635. Giacomo era sposato ed ebbe figli e un nipote; ma la famiglia sembra essersi estinta con questo nipote nel 1700. [Karl Inama, scrive che Giacomo aveva sposato una certa Domenica, dalla quale nacquero i figli Giuseppe Vittore (n.1655) e Giuliana (n.1656); Giacomo però, risulta morto già nel 1642, all’età di 18 anni, e quindi è poco probabile che si fosse sposato e avesse avuto discendenti. C’è da presumere che il Giacomo marito di Domenica, fosse il figlio di Cipriano II°,V. Tav. 26 ]. Vittore e Maria morirono nello stesso giorno, il 24 maggio 1641. [Dai registri la morte di Vittore risulta il giorno 14 maggio 1642]
2.1.5. SILVESTRO (1600-1681) FIGLIO DI VITTORE, I SUOI FIGLI ED I SUOI NIPOTI
Silvestro, nato nel 1600 circa, fu il capostipite della maggior parte delle famiglie che successivamente e ancora oggi vivono a Dermulo e a Taio o che da qui provengono. Anche egli era chiamato magnificus dominus come pure messer e quindi possiamo dedurre che fosse notaio. Sono stati trovati documenti solo dei suoi ultimi anni, fino al 1681. Un documento di questo anno si riferisce alla quota di eredità del nonno e paterna di suo nipote con lo stesso nome, Silvestro, che voleva diventare prete. In quel tempo era descritto come un uomo molto vecchio e malato (in gravi senectute constitutus). Il 1 novembre dello stesso anno fece testamento e morì pochi giorni dopo. Sua moglie Barbara [era una figlia di Giovanni Giacomo Bonadiman di Casez] morì il 25 dicembre 1685. Dal matrimonio nacquero, tra il 1629 e il 1645, nove figli; tre o quattro morirono in tenera età, altri tre o quattro raggiunsero la maturità ma rimasero scapoli. Due figli, Vittore, nato nel 1634 e Giacomo, nato nel 1637 iniziarono delle linee di cui si parlerà nei seguenti punti a) e b). a) Giacomo, 1637-1699, sposato con Maria Barbacovi, suo figlio Silvestro, nato nel 1674 e morto nel 1745, sposato con Margherita de Panizza, e suo nipote, di nome Giacomo Antonio, nato nel 1701 e morto nel 1782, sposato [dal 1732] con Barbara de Andreis [di Mechel], vissero a Taio. Furono persone di riguardo, l’ultimo nominato fu anche notaio. Gli fu dato, (oltre ai soliti titoli onorifici) anche il predicato nobilis.[Nel 1769 Giacomo, rimasto vedovo, si risposa con Brigida Barbacovi]. Mentre dal matrimonio di Giacomo con Maria Barbacovi sembra sia nato solo il figlio Silvestro, dai matrimoni di Silvestro (nato nel 1674) e del giovane Giacomo nacquero rispettivamente sette e sei figli. Questa famiglia, comunque, si estinse con la morte di Giacomo Antonio avvenuta nel 1782. Nel testamento, Giacomo Antonio incluse molti lasciti e nominò suo erede universale suo nipote il magnifico illustrissimo signore e dottore in lettere Antonio Alisio de Panizza. Nel testamento fu fatto obbligo all’erede di chiamarsi Inama-de Panizza e di abitare la casa ereditata a Taio (in seguito n. 78). Sembra che l’obbligo dell’ aggiunta del nome non sia stato rispettato o che lo sia stato solo per breve tempo. [Giacomo Antonio possedeva a Dermulo ancora una parte di casa n. 2/3, proveniente dalle divisioni dei beni del bisnonno Silvestro. Questa casa poi sarà venduta a Giacomo fu Michele Inama. V. Tav. 27. Come si può evincere dall’anagrafe del 1710 la suddetta casa era in quell’anno abitata da Silvestro e dalla sua famiglia]. b) Vittore, nato nel 1634, non fu da meno del padre e del nonno come posizione sociale; anche lui era chiamato magnificus dominus. Il 1 dicembre 1657 sposò Maria Busetti figlia di Ottavio. Dal matrimonio nacquero sette figli. Tre figli, Giovanni nato nel 1658, Silvestro nato nel 1659 e Vittore nato nel 1677 scelsero il sacerdozio, il primo, dopo gli studi in teologia fatti a Bologna, entrò nel convento di San Benno di Venezia (1688), il secondo, dopo la cura d’anime al suo paese come sacerdote, divenne archivista. Dei due fratelli non abbiamo ulteriori notizie né riguardo la loro vita né sulla loro morte. Vittore, il minore, intraprese studi di teologia a Venezia, diventò sacerdote e morì a Taio già nel 1704, ancora giovane a 27 anni. Ancora nel 1900 Giuseppe Inama conservava a Coredo la fattura del medico per spese sanitarie ammontante a 41 lire; questa riportava che le labbra erano piene del catarro dello stomaco e della ferita.(?) Una sorella dei fratelli sacerdoti morì ancora bambina, un’altra, Barbara, nata nel 1665, sposò nel 1685 Simone Leonardelli di Coredo ma nel 1704 era già vedova. Giovanni Giacomo, nato nel 1661, quarto figlio di Vittore e Anna Maria, diede origine a un ramo principale della famiglia [V. paragrafo 2.2.1.] mentre dal quinto figlio, Ottavio nato nel 1673, [V. paragrafo 2.2.2.] ebbe origine il secondo ramo principale degli Inama di Dermulo (in quanto appartengono alla discendenza di Rigolo). Il padre Vittore viene menzionato più volte a partire dal 1660 come padrino, testimone in atti giuridici e quale acquirente di terreni. Redasse il suo testamento nel 1689 e subito dopo aggiunse un codicillo con cui assegnava alla moglie l’usufrutto del suo patrimonio. Morì il 13 gennaio 1690. Solo nel 1695 il figli Giacomo [Giovanni Giacomo], Ottavio e Vittore si divisero l’eredità; Vittore, ancora minorenne, fu patrocinato dallo zio Giacomo Inama quale tutore. [Dal relativo documento risulta che era Ottavio l’assistito dallo zio Giacomo, mentre Vittore era assistito da Bartolomeo Fuganti]. Giacomo [Giovanni Giacomo], nato nel 1661, prese la casa dell Inama di sotto alla crosara, e cioè sotto il bivio, che il padre aveva sempre abitato e che aveva un grande orto e un prato circondato da un muro. Ottavio prese quella sopra al bivio [Come pure il fratello Vittore che poi però abbracciò il sacerdozio e quindi vi rinunciò]. L’asse ereditario immobiliare comprendeva inoltre un gran numero di prati, campi e boschi siti a Dermulo, Taio e Coredo. La madre Anna Maria Inama-Busetti redasse testamento nel 1701 a favore dei figli e morì nello stesso anno.
2.2. DA VITTORE (1634-1690) AI GIORNI NOSTRI
2.2.1. GIOVANNI GIACOMO FIGLIO DI VITTORE, I SUOI FIGLI E NIPOTI V. Tav. 31
Giacomo [Giovanni Giacomo], nato nel 1661 e morto nel 1731, oltre ai terreni ereditati sottoscrisse nel 1694 un contratto come affittuario e fattore con il Castel Brughier. Sembra che non abbia potuto far fronte ai suoi impegni poiché nel 1705 cedette al conte Giuseppe Giovanni Antonio Thun un prato di sua proprietà a Taio in conto pagamento e sciolse il contratto. Dei dieci figli nati dal suo matrimonio con Domenica Endrizzi[43] quasi tutti morirono ancora lattanti; l’ultimo, Giovanni Giacomo, nato nel 1704, continuò da solo la discendenza. Il contratto da affittuario non influenzò la sua posizione sociale; ufficialmente appare come magnificus dominus. Morì il 6 maggio 1731 dopo aver visto morire sua moglie già nel 1718. Giovanni Giacomo il giovane nacque il 3 aprile 1704 e morì intorno al 1780. Sembra che abbia lavorato, come contadino, terreni sia di sua proprietà che presi in affitto. Appare in documenti ufficiali dal 1730 in questa sua qualità e come padrino. Il primo maggio del 1726 sposò in prime nozze una tale Domenica, nel 1746 in seconde nozze una tale Maria e nel 1770 si sposò per la terza volta con una certa Domenica. Non conosciamo il nome di famiglia delle tre mogli. Solo un figlio per ciascuno dei primi due matrimoni raggiunse l’età adulta, tutti gli altri morirono ancora bambini, e una figlia che rimase nubile. I figli furono un Giacomo nato nel 1727 che morì nel 1780 circa (fu notaio in Taio, sposato con Marina Rollandini di Mollaro, i figli di questo matrimonio, però, morirono ancora bambini e solamente una figlia diventò adulta e sposò Pietro Magnani nel 1778) e un certo Francesco, dal secondo matrimonio del padre, che nacque nel 1746. Questi, sposatosi nel 1768 con Francesca figlia di Tomaso Ioris di Portolo, è il capostipite di una numerosissima discendenza che oggi rappresenta il primo ramo degli Inama di Dermulo. Vedi paragrafo 2.2.1.1. qui sotto.
2.2.1.1. GIOVANNI FRANCESCO FIGLIO DI GIOVANNI GIACOMO
Con Francesco (1746-1819), che noi dobbiamo considerare come il più vicino capostipite del primo ramo degli Inama di Dermulo, inizia la storia più recente di questa linea. Il grande numero di figli, anche se l’alta mortalità infantile la riduceva di molto, dovette portare a successive ripartizioni del patrimonio e quindi a una riduzione dell’asse patrimoniale. Nelle iscrizioni dei registri ecclesiastici viene ancora detto magnificus. Fu l’ ultimo a cui fu dato questo titolo di distinzione. I figli svolsero il lavoro manuale di carpentiere e di tessitore e lo stesso Francesco quello di frustaio che successivamente passò al figlio Giovanni. Il patrimonio di Francesco, come risulta dall’inventario da lui stesso fatto nel 1817, era ragguardevole; aveva un valore di 7.300 Ràgnesi. Con la morte di Giacomo Antonio Inama (nato il 27 ottobre 1701 e morto nel 1782) avvenuta a Taio, aveva ereditato terreni a Taio dove si trasferì nel 1780 circa. La famiglia visse nella casa al numero 80 di proprietà del conte di Thun. Nel 1790 si recò in pellegrinaggio a Roma dove poté parlare con il papa Pio VI e il 17 gennaio 1791 ottenne una bolla d’indulgenza per sé, i suoi famigliari più stretti e per dodici altre persone delle famiglie Panizza, Mendini, Barbacovi, Widmann, Rizzi e altre. Questa bolla papale è probabilmente andata perduta. Francesco si sposò a Nanno il 28 settembre 1768 con Francesca Ioris, una figlia di Tomaso Ioris di Portolo, che gli diede quattordici figli. Di questa moltitudine, otto figli morirono da bambini o da giovani. [La figlia Maria sposò il mugnaio Giambattista Paternoster di Cloz, un’altra figlia di nome Caterina andò in moglie a Giuseppe figlio di Giuseppe Cordini di Taio ed il figlio Pietro sposò Marianna Sicher di Coredo. Da questo matrimonio nacquero fra il 1800 ed il 1814 cinque figli che però morirono prematuramente].[44] Ma quattro figli di Giovanni Francesco fondarono delle famiglie e sopravvivono attraverso una numerosa discendenza. Questi quattro figli furono:
a) Giacomo Antonio, nato nel 1771, m. nel 1846 b) Giovanni, nato nel 1774, m. nel 1832 c) Baldassarre, nato nel 1783, m. nel 1855 d) Antonio, nato nel 1790, m. nel 1864
Francesco fece testamento il 2 gennaio 1819 e morì lo stesso giorno; già undici anni prima aveva dato ai cinque figli la maggior parte dei suoi beni immobili il cui valore, ad ogni buon conto, fu stimato in 1.100 Ràgnesi. Otto anni dopo la moglie Francesca lo seguì nella tomba.
2.2.1.1.1. GIACOMO ANTONIO FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO V. Lista n. 7
Giacomo Antonio, spesso chiamato solo Giacomo, di professione carpentiere, falegname e bottaio, era il figlio maggiore di Giovanni Francesco, era nato infatti nel 1771. Dal matrimonio con Maddalena Pedrotti figlia di Giovanni di Dambel nacquero sei figlie ed un figlio di nome Filippo che sposerà nel 1870 Augusta Eccher figlia di Lorenzo e sorella di Felice. Le figlie si chiamavano Giovanna, Maria, Luigia, Teresa, Francesca e Monica, che sposarono rispettivamente Ferdinando Portolan, Andrea Rigotti, Lorenzo Bertol, Luigi Zambiasi, Marino Zambiasi e Felice Eccher di Dermulo. L’abitazione di Giacomo Antonio era nella parte occidentale della casa n. 27, dove abiterà pure il nipote Giacomo figlio di Filippo. Gli eredi di Giacomo poi, negli anni Quaranta del Novecento, venderanno la casa per abitare in quella nuova poco distante numerata con il 40. La discendenza maschile di questo ceppo Inama si estingue proprio con Giacomo, essendo nate dal suo matrimonio con Maria Depaoli figlia di Giuseppe, ben dieci femmine. Nelle tre ultime generazioni su 22 nascite solo tre sono maschi. Giacomo aveva tre sorelle fra le quali Fortunata, che sarà moglie di Celeste Inama. Fortunata di nome ma non di fatto, vista la sua tragica morte nel 1945, durante l’ultima guerra mondiale.[45] (Leggi la poesia di Ida Seppi)
2.2.1.1.2.GIOVANNI FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO
Giovanni, il figlio di Francesco nato nel 1774, seguì il padre nella sua attività di frustaio che questi aveva posseduto a Taio. Mediante una cooperativa commerciale fondata allo scopo poté allargare in modo considerevole questa attività così da fornire non solo l’Austria ma anche esportare in Svizzera, Germania, Francia e America. Giovanni era sposato dal 1805 con Margherita Menapace di Pavillo che gli diede 12 figli. Anche se pure in questo matrimonio 5 figli morirono nella prima giovinezza, da sei figli ebbero origine numerose discendenze. Tra i discendenti di Giovanni ci furono dei nipoti che si trasferirono nel Vorarlberg e a Weiler nell’Allgaeu bavarese. Queste linee vivono ancora. I pronipoti e i tanti figli dei pronipoti hanno raggiunto un numero considerevole e mostrano rami ancora ben vivi. Anche in America dovrebbero esserci ancora dei discendenti. Di Giovanni[46] che si era trasferito a Taio ai primi dell’Ottocento, ricordiamo il figlio maggiore Luigi nato nel 1812, sposato con Romana Formolo ed abitante a Dermulo nella casa paterna n. 27. Nel 1852 apprendiamo da una carta presente nell’archivio comunale che Luigi era assente da Dermulo da più di un anno. Infatti raccorciando capelli, girovagava di paese in paese in cerca di clienti. Nel 1855 era a Dermulo, dove morì a causa del colera. Dal matrimonio nacquero tre figli: Luigi (n.1841), Angela (n.1848) e Colomba (n.1850). Luigi morirà celibe a Montecchio nel 1864 dove aveva intrapreso un attività di commercio di chincaglie[47], Colomba muore diciassettenne nel 1867, Angela invece sposerà nel 1865, Giuseppe Endrizzi figlio di Giovanni. Molti terreni oggi proprietà Endrizzi provengono proprio dall’eredità di Angela.
2.2.1.1.3. Baldassarre FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO V. Lista n. 2
Baldassarre Inama detto Rodar di professione tessitore, abitava con la sua famiglia nella casa n. 27. Sposato con Caterina Vit di Tuenno aveva avuto quattro figli: Maria, Pietro, Giuseppe e Baldassarre. Maria nata nel 1817 sposa Giacomo Inama Sèp. a) PIETRO nato nel 1819 sposa Teresa Mendini e lascia la casa paterna per abitare nella casa n. 20-21 della moglie. Pietro detto Guslot, aveva 4 figli: Elia, Emanuele, Germano e Maria; di questi solo Elia si sposa, Emanuele muore celibe nel 1871 all’età di 25 anni, Germano fugge in America senza dare più sue notizie e Maria vivrà nubile nella casa n. 20 fino alla sua morte avvenuta nel 1925. Elia si sposa due volte, la prima con Alceste Sandri di Priò, la seconda con Santina Corazzola di Tres[48]. Dal primo matrimonio nascono nel 1891 Attilio, e nel 1893 Silvio. Attilio si sposa con Maria Inama figlia di Ferdinando e avrà solo un figlio di nome Tullio che oggi vive in Argentina. Silvio sposa Bruna Endrizzi di Don e dal matrimonio nasceranno due figlie Carmela e Ilda; l’ultima vive tuttora nella casa costruita nel 1926 dal padre e dal nonno materno di Don. Germano nato nel 1850, per qualche anno è maestro nelle scuole elementari del paese, dal 1886 al 1888 fu anche Capocomune. Sembra che la sua improvvisa partenza per l’ America sia stata proprio dovuta a qualche problema legato all’incarico di Capocomune. Rimane il fatto certo della vendita all’asta della sua casa n. 21, e relativa acquisizione da parte del Comune. b) GIUSEPPE nato nel 1821 sposa Brigida Inama figlia di Giovanni Sèp e abita nella casa n. 27. Dal matrimonio nascono sette figli fra cui: Emilia che sposerà Agostino Inama figlio di Baldassarre Zitol, Maria che sposa Fortunato Eccher, Geremia che sposa Emilia Inama figlia di Giovanni Fógia e Clemente che sposa Annunziata Vegher. Dal matrimonio di Geremia con Emilia nasce solo una figlia di nome Vittoria che poi sposerà Emanuele Sandri di Tuenno.[49] Nel 1902 Geremia è nominato curatore dei figli minori di Basilio Emer dimoranti in Brasile, incarico che smetterà nel 1927 per limiti di salute ed età. Clemente e Annunziata invece non ebbero nessun figlio. Annunziata fu per un periodo la mammana di Dermulo. Clemente costruisce nel 1912 la casa nella località al Ciapitel poi numerata con il 41. Erede della casa e di alcuni campi è nominata Emma Inama, nipote di Clemente. c) Baldassarre il figlio più giovane di Baldassarre era nato nel 1824 e abitava con la moglie Marianna Bonadiman nella casa n. 5.[50] Dei suoi tre figli, Augusto nato nel 1856 si trova negli U.S.A. già nel 1886 e non darà più sue notizie; Felice nato nel 1860 ed Emanuele nato nel 1865 erano sposati rispettivamente con Elena Poloni e Maria Bertagnolli.[51] Felice, dal 1888 assunse l’incarico di custode forestale per il comune di Dermulo, percependo un compenso di 40 fiorini annui. Dai due sopraccitati matrimoni nacquero una figlia ciascuno e cioè: Irene e Ester.
2.2.1.1.4. ANTONIO FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO V. Lista n. 3
Antonio era il figlio più giovane di Giovanni Francesco essendo nato nel 1790. Egli non abiterà all’inizio nella casa paterna come gli altri fratelli, ma nella casa n. 5, una volta casa Endrizzi. Dal matrimonio con Elisabetta Parolini di Banco nacquero sei figli di cui tre raggiungeranno l’età adulta: Francesca (1815) che sposerà Giovanni Massenza ed abiterà al maso Rauti, Giuseppe (1821) e Giovanni (1823). a) GIUSEPPE detto Bomba, si sposa due volte: la prima nel 1856 con Filomena Emer figlia di Romedio dal cui matrimonio nasceranno Ferdinando, Modesto, Romedio e Candido, la seconda con Leopolda Zucal che darà alla luce Angelo. Giuseppe abiterà nella casa n. 26, presumibilmente ereditata dallo zio Pietro morto nel 1848. In detta casa poi abiteranno con le rispettive famiglie il figlio più vecchio Ferdinando e il più giovane Angelo, gli altri tre figli Modesto, Romedio e Candido emigreranno verso il 1895 negli U.S.A.[52] Nel 1905, Giuseppe trasferì la casa ed altri due terreni in proprietà dei due figli Ferdinando e Angelo con l’obbligo però che si dovessero occupare del suo sostentamento. Ferdinando nato nel 1857 sposa Rachele Eccher figlia di Felice. Dal matrimonio nasceranno dieci figli fra i quali Emilio e Guido che emigreranno negli Stati Uniti a Shepton, dove moriranno senza famiglia; Giacomo si trasferirà a Rovereto, Felice e Lorenzo si sposeranno e abiteranno in paese. Ferdinando alla fine dell’ Ottocento lavora i campi che i Panizza di Taio possiedono a Dermulo ed è spesso nominato negli atti comunali come ispezionante del bestiame e delle carni macellate. Modesto nato nel 1859 quando ritorna dall’America si sposa con Ottilia Bonadiman di Banco e abita nella casa n. 3[53] presumibilmente comperata dagli eredi di Urbano Inama Valentin. Il suo unico figlio maschio di nome Vittorio lascerà Dermulo per raggiungere la Francia, dove morirà celibe. Romedio nato nel 1861, sposa nel 1893 Diomira Barbacovi di Taio e nello stesso anno lascerà il paese ed emigrerà negli U.S.A. A Bridgeport nell’Ohio, nasceranno tra il 1894 e il 1900 quattro dei suoi sei figli e cioè: Luigi, Maria, Modesta e Giuseppe. La moglie Diomira si occupava anche di altri emigrati di Dermulo, preparando loro il cibo e rattoppando vestiti[54]. Nel 1903 Romedio torna a Dermulo, abiterà in affitto nella casa n. 24, ed intanto progetta e costruisce una casa numerata poi con il 34. Romedio aspirerebbe di aprire nella sua nuova casa un’osteria, ma dovrà aspettare ben quattro anni affinché dopo innumerevoli richieste al Comune il suo desiderio si avveri. La discendenza di Romedio proseguirà con il primogenito Luigi, l’altro figlio di nome Giacinto muore tragicamente nel 1912 all’età di quattordici anni. Infatti mentre le sue vacche pascolavano alle Plazze, precipitava in un burrone in località Val Sécia sembra a causa di un’imprudenza nel recuperare un nido. Candido nato nel 1869 sposa Assunta Barbacovi di Tres[55]. Anche lui emigrerà temporaneamente in America nelle miniere d’oro a Central City in Colorado dove nasceranno i primi tre figli: Elviro, e le gemelle Maria ed Emilia. Qualche anno dopo anche Candido ritorna in paese ed inizialmente abiterà in affitto nella casa n. 18; poi nel 1909 si presenta l’occasione di acquistare la casa n. 9 da Desiderato Endrizzi. Qui nasceranno: Remo, Fiorina, Attilia e Ida. La discendenza di Candido in linea maschile è oggi estinta, infatti Elviro sarà conventuale alla Basilica di S. Antonio di Padova con il nome di padre Bernardo, Remo invece rimarrà celibe. Angelo nato nel 1878 dal secondo matrimonio di Giuseppe, sposa nel 1911 Maria Tamè figlia di Costante e abita nella casa n. 26 ancora oggi abitata da suo figlio Aldo. b) GIOVANNI detto Zanet abita in una parte di casa n. 5, e sposa nel 1857 Basilia Calliari. Dal matrimonio nascono sei figli fra cui Beniamino, Daniele e Giuseppe. Beniamino nato nel 1858, sposa Filomena Inama figlia di Eugenio dalla quale avrà tre figli: Maria, Lino e Rina. Quest’ultima sposerà Vittorio Inama di Dermulo, Maria invece Pio Demagri di Cles. Per un breve periodo Beniamino risiederà negli U.S.A.[56] Dal matrimonio di Lino con Giuseppina Borzaga di Ronzone nasceranno due figlie che saranno le ultime proprietarie della casa n. 5 e anche le ultime Zanete a Dermulo. Daniele nato nel 1863, sposa Annunziata Tavonatti e abita almeno dal 1894 nella casa n. 10. Le sue quattro figlie: Gisella, Angelina, Maria e Anna, venderanno la casa a Adolfo Odorizzi di Rallo. Daniele possedeva anche una costruzione adibita a casa rustica e stalla, venduta da lui stesso a Felice Ambrosi di Trento.[57] Giuseppe nato nel 1865 emigra negli U.S.A. senza dare più nessuna notizia. Dovrebbe però aver abitato ad Hazleton in Pennsylvania, dove forse oggi c’è qualche discendente. Nel 1888 era partito assieme a lui anche il fratello Daniele ma poi questo era ritornato a Dermulo.
2.2.2. OTTAVIO FIGLIO DI VITTORE
Ottavio nacque a Dermulo il 10 maggio 1673 e visse con la sua famiglia nella casa n. 26 fino al 1702, anno del suo matrimonio con Lucia Fedrizzi di Toss. In seguito alle nozze, si trasferì nella porzione E della casa n. 2-3. In occasione del matrimonio, don Pietro Fedrizzi, zio di Lucia, dispose nel suo testamento una donazione di 60 ragnesi a favore della nipote. Tuttavia, come spesso accadeva all’epoca, il marito Ottavio, avendo un debito di pari importo con Vittorio Emer, gli cedette il diritto di esigere la somma dagli eredi di don Pietro. Nel 1705, Vittorio Emer trasferì a sua volta tale diritto a Lorenzo Magnani di Sfruz e questo ad Andrea Marcolla di Vigo. In relazione a questa donazione, nel 1712 Ottavio intestò alla moglie Lucia un prato con bosco contiguo alla Pozzata (p.f. 466). Nel 1711, Ottavio ricevette dal suocero Andrea Fedrizzi di Toss la somma di 335 ragnesi e due troni e mezzo, a titolo di dote per Lucia. Contestualmente, egli assegnò alla moglie, come restituzione di parte della dote, un terreno al Blaum (p.f. 423, 424, 428, 429 e 430). Dall’unione di Ottavio e Lucia nacquero cinque figli. Di questi, tre maschi — Vittore (n. 1703), Giovanni Giacomo (detto Giacomo, n. 1709) e Silvestro (n. 1712) — e una femmina, Anna Maria (n. 1714), raggiunsero l’età adulta. La storia dei discendenti dei tre fratelli maschi sarà trattata nei prossimi capitoli. Anna Maria, invece, nel 1746 sposò Andrea, figlio di Michele Refatti di Taio. In occasione delle nozze, i fratelli Vittore, Giacomo e Silvestro, insieme alla madre Lucia, da poco rimasta vedova, le assegnarono una dote di 25 ragnesi ciascuno, per un totale di 100 ragnesi. A questi si aggiunsero i doni dei cugini: Giovanni Giacomo Inama, che le offrì 2 ragnesi, e Giacomo Antonio fu Silvestro Inama, più agiato, che contribuì con 50 ragnesi. Ottavio entrò in possesso della propria quota dell’eredità paterna nel 1695, quando si procedette alla divisione dei beni con i fratelli Giovanni Giacomo e Vittore. Tale spartizione avvenne in contravvenzione al codicillo del testamento redatto dal padre Vittore nel 1690, il quale disponeva che i figli rimanessero in comunione dei beni dopo la sua morte. Poiché all’epoca, Ottavio non aveva ancora raggiunto la maggiore età, fu assistito nelle operazioni di assegnazione dallo zio Giacomo Inama. Per prima cosa fu divisa la casa di sopra, della quale Ottavio venne in possesso della porzione E, e metà dell'orto posto nelle vicinanze (p.f. 159, 160, 161 e 162) che però rimase in comproprietà con il fratello Vittore. Per quanto riguarda i terreni a Ottavio venne assegnato: un arativo e vignato detto a Pian (alle Braide) (p.f. 878/6 e 878/7), "la parte sotto la strada, compreso degli alberi, ad esclusione del pero nei pressi del prato"; un arativo e vignato sotto la casa vecchia Inama (p.f. 123 e 127, Sotto le Case); la terza parte dell'arativo vignato alle Bertuse (p.f. 305 e 306), una vaneggia con una stregla alla Cros (p.f. 318, 319 e 320, alle Berte), un arativo e vignato a Cambiel con due alberi di pero e una quercia (p.f. 376), una arativo e vignato al Blaum (p.f. 423, 424, 428, 429 e 430), (questo però in comproprietà con Vittore), un arativo vignato a Cavauden (p.f. 528 alla Sgolma), un'altra parte di campo a Cavauden (p.f. 521 e 522), un campo a Campovecchio (p.f. 541 e 542), un campo al Gomer (p.f. 460, 461 e 468), un prato alli Visenzi (p.f. 594 e 595), un prato a Rizzai (p.f. 551 e 552 porzioni 1), un prato a Pramartinel (p.f. 89), un altro prato a Pramartinel detto ai Fuganti (p.f. 87/3, 87/4 e 87/5), una sorte di pini alle Fontanele e una a Rizzol (detta la sorte della Lavina), entrambe pertinenze di Coredo, una sorte di pini alle Sabionare (p.f. 454, alla Ciaseta), una sorte di pini entro al Ridal (p.f. 717, 718, 719, 720, 723, 726 alle Voltoline), una sorte di roveri Sotto Sas (p.f. 73, 74, 75, 76, porzione del bosco alla Bertolda), una sorte di roveri alle Fasse (p.f. 229 e 230), e infine, una sorte di roveri al Cambiel di Sotto, con piccolo prato e due vaneggie arative e vignate (p.f. 388, 389, 392 e 393). Siccome il fratello Giovanni Giacomo aveva in locazione il maso di Castel Bragher e quindi era impossibilitato a coltivare i terreni di Dermulo, li concesse in affitto ai suoi fratelli Ottavio e Vittore. I beni ereditati dal padre costituivano già un patrimonio di tutto rispetto, sebbene su parte di essi gravassero consistenti capitali presi a prestito. Inoltre appartenevano ad Ottavio altri terreni non menzionati nel predetto elenco, quali i terreni livellari Panizza, alla Tonda (p.f. 486 e 487), alla Ciaseta (p.f. 494 porzione 1, 495, 496 e 497), e a Cavauden (p.f. 520); i terreni al Campo Cordin (p.f. 492 e 493), alla Ciaseta (p.f. 494 porzione 2) e a Rizzai (p.f. 551 e 552 porzione 3) livelli della canonica di Sanzeno, la cui investitura relativa ad Ottavio risaliva al 1704. Ancora il prato e bosco alla Pozzata detto anche Busa (p.f. 466 porzione 2 e 3). Alla morte prematura del fratello don Vittore, nel 1705, il patrimonio di Ottavio si accrebbe ulteriormente con l’acquisizione di nuovi terreni: due prati a Pramartinel, la piena proprietà dell’orto alla Crosara e dell’arativo vignato al Blaum, beni che in precedenza erano condivisi con lo stesso Vittore. Poco dopo, Ottavio ottenne anche alcuni beni che la sorella Barbara aveva ereditato da Vittore, tra cui le porzioni B e C della casa n. 3, una parte del terreno a Ronc (p.f. 659, 660) “con una stregla a vino e una a grano”, e il campo a Cavauden (p.f. 510 e 511) detto alle Glare o ai Sassi. Considerati alcuni accomodamenti e gli oneri che spettavano a Barbara, si concordò che Ottavio avrebbe versato per tali beni la somma di 90 ragnesi. Per saldare l’importo, nel 1706 egli le cedette la propria porzione di prato a Rizan, nelle pertinenze di Taio. Come già accennato, la quantità di beni terrieri poteva essere considerata un indice di relativa agiatezza. Tuttavia, Ottavio sembra aver attraversato un periodo di difficoltà economiche che lo portò, in seguito, a vendere gran parte delle sue proprietà fondiarie per ottenere liquidità.
Nel 1698 Ottavio necessitava
di 40 ragnesi, somma che prese in prestito da Floriano Inama di Fondo,
garantendone la restituzione con un’ipoteca sul terreno detto
Sotto le Case e sul prato
ai Fuganti. Nel 1716 permutò il terreno a Cavauden, detto alle Glare (p.f. 510 e 511), con un campo situato a Friscolan, nelle pertinenze di Taio, di proprietà di Lucia Refatti, moglie di Enrico Endrizzi. Ottavio cedette poi il campo di Taio ai fratelli Giovanni e Domenico, figli del fu Cristoforo Emer. Sempre nel 1716 vendette a Antonio Mendini il grande prato ai Visenzi (p.f. 594 e 595) e avendo ancora bisogno di denaro, prese in prestito dalla comunità di Dermulo 38 ragnesi. Come garanzia sottopose il terreno a Campovecchio e l'orto alla Crosara. Nel 1720 vendette a Giovanni Emer di Taio per 36 ragnesi un bosco Sotto le Case (p.f. 114) e nel 1722 al cugino Silvestro Inama di Taio una parte di prato a Pramartinel. Nel 1723 Giovanni Giacomo venne in aiuto del fratello Ottavio, saldando per suo conto una somma di 50 ragnesi dovuta a Carlo Conci di Tres, a titolo di restituzione di un prestito in denaro e di una fornitura di grano. A garanzia di tale operazione venne iscritta un’ipoteca a favore di Giovanni Giacomo su un terreno arativo a Cavauden, nelle pertinenze di Dermulo, e su un altro arativo situato nelle stesse pertinenze, detto a Rizzai. Il debito verso il fratello risultò estinto nel 1726. L’anno successivo, nel 1724, Ottavio vendette a Giovanni Bertolini di Cles “un luogo arativo, streglivo, con due pomari e altri arbori” situato alle Bertuse(p.f. 305 e 306). Nello stesso periodo risulta inoltre l’esistenza di un cospicuo debito di 200 ragnesi, derivante da due capitali concessi in prestito nel 1687 e nel 1689 al padre Vittore dalla famiglia Busetti. Tale passività, garantita da un prato a Pramartinel, era passata in eredità a Ottavio, cui i Busetti chiesero la restituzione del capitale. Poiché il prato ipotecato non risultava sufficiente a coprire l’intera somma, intervennero don Pietro Panizza e Silvestro Inama, che si offrirono di saldare il debito, aggiungendo altri 60 ragnesi a titolo di interessi. Nel 1726 vendette a Giovanni Francesco Barbacovi di Taio un bosco alle Sabionare ossia a Pontalto per 27 ragnesi. Nel 1727 in relazione a un debito con il massaro Giovanni Andrea Giuliani di Nanno, gli cedette una parte di terreno a Ronc p.f. 659, 660, ossia due stregle di grano e una di vino per 72 ragnesi. Due anni dopo però Ottavio ricomprò il terreno per lo stesso prezzo. Nel 1730 Ferdinando Panizza, erede del padre Pietro Lorenzo, esaminando le carte paterne si accorse di alcune pendenze riguardanti Ottavio Inama. In particolare, intorno al 1714, Ottavio aveva venduto a Pietro Lorenzo Panizza un terreno alle Berte, sul quale però gravavano alcuni capitali prestati in precedenza da don Pietro Panizza. L’ammontare di tali capitali era di 100 ragnesi, ai quali si aggiungevano 25 ragnesi di interessi. Non disponendo della somma necessaria, Ottavio trasferì a Ferdinando un terreno arativo e un bosco al Blaum. Poiché su tale proprietà era assicurata la dote della moglie Lucia, egli provvide a spostare tale garanzia sulla loro casa alla Crosara. Una situazione analoga si verificò per il terreno al Pramustel, gravato da un censo a favore di Pietro Lorenzo Panizza, contratto da Vittore, padre di Ottavio, che in seguito aveva ceduto il fondo ad Alberto Inama di Fondo. Anche in questo caso, Ottavio trasferì l’obbligazione sulla propria casa alla Crosara. Tra le varie alienazioni, Ottavio aveva dovuto cedere anche una porzione del terreno a Ronc (p.f. 659, 660) a Giovanni Giorgio Matteo Widmann di Coredo. Tale bene fu tuttavia riacquistato nel 1745 dal figlio Giacomo per la somma di 100 ragnesi. Nel 1710 Ottavio rivestiva l'incarico di regolano, allorchè gli abitanti di Dermulo aveva manifestato l’esigenza di avere un sacerdote che, dal primo novembre al primo maggio, celebrasse la messa nei giorni festivi nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Per raccogliere l’onorario del primissario, la comunità, riunita in regola, presentò le proprie offerte. Ottavio per primo diede il buon esempio, promettendo una donazione di 40 ragnesi, garantiti su un terreno arativo e vignato a Cambiel. Nel 1724 troviamo Ottavio a Sfruz, dove si era recato presso Vittore Parteli — che, peraltro, si trovava a letto ammalato — al fine di risolvere, anche a nome del fratello Giovanni Giacomo, una controversia relativa all’acquisto di due manzi. Da quanto si può dedurre, gli animali non rispondevano alle aspettative degli acquirenti, e Ottavio intendeva probabilmente restituirli oppure ottenere una riduzione del prezzo. La disputa richiese l’intervento, in qualità di mediatore, perfino del parroco di Sfruz, don Michele Antonio Tavonatti. Nel 1730, Ottavio intraprese una lite con i cognati Matteo e Giovanni Fedrizzi in merito all’eredità della suocera e madre Anna Domenica Tecini, del valore complessivo di 775 ragnesi. Ottavio rivendicò la quota legittima, che i fratelli Fedrizzi valutarono in soli 10 ragnesi. Non ritenendo equa tale cifra, Ottavio — con la mediazione di Salvatore Depero di Toss e dopo vari aggiustamenti — raggiunse un accordo per 37 ragnesi. Quest'ultimo importo fu assicurato da Ottavio su un gaggio alle Sabionare, (p.f. 454) e su un terreno a Ronc (p.f. 659, 660). Nel 1735 Ottavio risultava debitore del fu Francesco Cristoforetti di Taio e, per estinguere in parte tale obbligazione, trasferì ai suoi eredi un bosco di roveri situato alla Pozzata (p.f. 466), il cui valore fu detratto dall’importo dovuto di 24 ragnesi.
Il 17 luglio 1745, seduto a tavola nella stua della propria abitazione, il magnifico Ottavio, alla presenza di numerosi dermulani, redasse il suo testamento. Nel documento, oltre alle consuete disposizioni di rito, lasciò ai figli Giacomo e Silvestro un campo e un prato situati alla Ciaseta; alla figlia Anna Maria destinò, quale dote, la somma di 60 ragnesi, oltre ai mobili già ricevuti; alla nuora Margherita, moglie di Giacomo, assegnò la casa in cui gli sposi abitavano in quel momento. Alla moglie Lucia concesse l’usufrutto della loro abitazione, mentre per il resto dei beni nominò eredi i tre figli Giacomo, Silvestro e Vittore, in parti uguali. Ottavio morì il 12 dicembre dello stesso anno, 1745, la moglie Lucia gli sopravvisse per undici anni. In sintesi, al momento della morte di Ottavio, del suo un tempo cospicuo patrimonio, restavano ormai pochi beni: la casa alla Crosara con i relativi orti (p.f. 159, 160, 161 e 162), il terreno a Campovecchio (p.f. 541 e 542), un campo al Gomer (p.f. 460, 461 e 468), il terreno a Rizzai (p.f. 551 e 552 porzioni 1) — comprensivo di quello posseduto a livello —, un bosco alle Fontanele, uno a Rizzol, un terreno con bosco alle Voltoline (p.f. 717, 718, 719, 720, 723, 726), i terreni alla Tonda (p.f. 486 e 487), alla Ciaseta (p.f. 494), soggetti a livello della famiglia Panizza, e infine un terreno a Cavauden (p.f. 521).
2.2.2.1. GIACOMO III FIGLIO DI OTTAVIO
Giacomo, (qualche volta chiamato anche Giovanni Giacomo) figlio di Ottavio era nato nel 1709 e morto intorno al 1788. Nel 1734 Giacomo sposò Margherita Bergamo di Portolo dalla quale ebbe nove figli. Fra questi, sicuramente sei raggiunsero l’età adulta e cioè Giovanni Battista, Giacomo Floriano, Giuseppe, Lucia, Anna Maria e Maria. I figli nati tra il 1734 e il 1749 videro la luce a Dermulo, mentre i più giovani, nacquero a Brescia dove Giacomo si era trasferito nel 1742. Il motivo del trasferimento di Giacomo rimane tutt’oggi sconosciuto, poiché i pochi documenti da me consultati, riferiti alla famiglia Inama in quella zona, risalgono alla fine del XVIII secolo e all’inizio del XIX. Per analogia con altre famiglie originarie di Dermulo emigrate nel bresciano, si può ipotizzare che Giacomo avesse inizialmente trovato lavoro come bracciante agricolo stagionale, per poi dedicarsi a un’attività artigianale più redditizia. È quindi plausibile che, intravedendo l’opportunità di migliorare le condizioni di vita proprie e della famiglia, avesse deciso di trasferire l’intero nucleo familiare. Alla morte del padre Ottavio, Giacomo aveva ereditato la parte est della casa "Sopra la Crosara" n. 2/3, (porzioni A E e G) ma per diversi anni, trovandosi in Lombardia, non vi abitò se non sporadicamente. Tra i fratelli, Giacomo si dimostrò il più intraprendente e attivo e ciò è comprovato dalla grande mole di documenti che in qualche modo lo riguardano. Se il padre Ottavio si era distinto per aver alienato la maggior parte dei terreni ereditati, Giacomo, almeno inizialmente, cercò invece di incrementare il proprio patrimonio. Un aiuto considerevole in tal senso gli venne da Giacomo Antonio Inama di Taio, che nel 1749 gli trasferì alcuni terreni con la formula dell’investitura perpetuale. Si trattava di un arativo a Rizzai, dell'arativo vignato al Bertus (p.f. 601–602), dell’arativo vignato al Bertusel (p.f. 605) e di un campo a Cavauden (p.f. 604) sotto la strada, nelle pertinenze di Sanzeno. Il canone annuo fu stabilito in tre stari di frumento, due di segala e uno di panizzo (miglio). Il conduttore Giacomo avrebbe potuto affrancarsi entro trent’anni corrispondendo il valore dei terreni. Con una seconda locazione del 1751, Giacomo Antonio gli trasferì un altro arativo e vignato al Plazzec, per un canone di due stari di segala. In uno dei suoi testamenti (1776), Giacomo Antonio Inama dispose l’esonero di Giacomo dal pagamento dei canoni sui terreni da lui posseduti a livello. Non è però noto se tale disposizione sia stata confermata nei successivi atti testamentari o sostituita, come parrebbe nel 1782, da un legato di 20 ragnesi. Nel 1782 Giacomo Antonio vendette a Giacomo anche un bosco alla Pozzata (o al Gomer) per 36 ragnesi. Sul finire degli anni Cinquanta del Settecento, Giacomo ricevette in locazione perpetuale da Francesco Rizzardi di Coredo l’arativo vignato a Sas (p.f. 51, 52, 56 e 57), con un canone annuo di quattro orne di brascato. Nel 1761 egli prese in considerazione l’idea di rinunciare alla locazione, ritenendo il canone troppo gravoso, ma riuscì infine a raggiungere un accordo con il Rizzardi, che ridusse il canone a due orne e mezza di brascato. Nel 1767 Giacomo si affrancò dal livello mediante il pagamento di 80 ragnesi, acquisendo la piena proprietà del terreno. Nel luglio del 1745, poco prima che il padre morisse, aveva riacquistato dai Widmann una porzione di terreno a Ronc per l'importo di 100 ragnesi. Su tale campo era stata trasferita l'assicurazione sul prestito di 40 ragnesi che il fu Ottavio aveva ricevuto da Floriano Inama nel 1698. Nel 1750 Bartolomeo fu Giovanni Mendini concesse in locazione perpetuale a Giacomo due terreni arativi e vignati al Plazzec per un canone di due stari di segala e uno e mezzo di frumento. Nello stesso anno, Giacomo vendette il campo a Ronc a Giovanni Battista Inama per 250 ragnesi. Della somma, 110 ragnesi erano già stati versati al venditore, mentre per il rimanente Giovanni Battista si accollò due capitali: 100 ragnesi presso Giorgio Matteo Widmann e 40 ragnesi presso Bartolomeo Inama di Fondo. Poiché sul terreno risultava assicurata la moglie Margherita, Giacomo trasferì tale assicurazione sul fondo di Rizzai e sulla casa di abitazione. Nel 1751 Giacomo ricevette da Giuseppe Tommaso Bombarda di Coredo l’investitura perpetuale di due ulteriori terreni, uno alla Tonda (p.f. 486 e 487), e uno alle Spinate (Cambiel). Nel 1749 egli aveva inoltre acquistato per 30 ragnesi dalla vedova di Giovanni Battista Cescati di Taio un bosco alle Voltoline, confinante con le sue proprietà. Nel 1753 e 1754 cedette al cugino Giovanni Giacomo due porzioni del terreno alle Voltoline; l’anno seguente fu quest’ultimo a trasferire a Giacomo un campo a Rizzai e un prato alla Pozzata, tenuti a livello dai Padri Gesuiti di Trento, ai quali si dovevano tre stari di frumento, tre di segale e uno di avena annui. Nel 1762 Floriano Inama di Fondo investì Giacomo di un terreno alle Braide e di uno a Rizan, con l’obbligo di migliorarli e di consegnare presso la casa di Dermulo cinque orne di brascato. Nel 1781 Giacomo acquisì, ancora come livello, alcune porzioni di terreno locate dal Comune, tra cui un fondo alla Croce di Rivalem, un grezzivo e lastivo a Rizzai e un bosco con roveri e abeti alle Spinate. Sul finire degli anni Cinquanta del Settecento Giacomo aveva acquistato un altra porzione di terreno a Cavauden sul territorio di Sanzeno, precisamente la parte posta a nord della p.f. 602, la quale però fu poi alienata a Antonio Inama.
Durante la sua vita, Giacomo contrasse diversi prestiti, principalmente per affrancarsi dai canoni dei terreni posseduti a livello: dalla chiesa di Dermulo (30 e 66 ragnesi nel 1749), dalla chiesa di Taio (80 ragnesi nel 1767), da quella di Coredo (40 ragnesi nel 1782), e da Anna Bombarda di Coredo (50 ragnesi nel 1769 e 100 nel 1777). Nel 1777 lo troviamo anche nella veste di “banchiere”, avendo concesso un prestito di 50 ragnesi al nipote Baldassarre Inama; nel 1781 delegò don Gaspare Chilovi di Taio alla riscossione del credito. Nel 1778 Giacomo onorò parte dei suoi debiti trasferendo i capitali dovuti a Giacomo Papa di Coredo, acquirente dell’arativo vignato al Plazzec, in luogo del pagamento diretto. Infine, nel 1783, decise di affrancarsi da un livello perpetuo di cinque orne di brascato dovute agli eredi di Romedio Chilovi. Per finanziare l’operazione, prese a prestito 100 ragnesi da don Giovanni Rosetta di Taio, garantendoli su un campo arativo e vignato alle Braide (p.f. 831, 7, 8, 829 nord). Al momento del matrimonio, la moglie Margherita, figlia di Valentino e di Anna Bergamo di Nanno, aveva portato in dote la somma di 150 ragnesi. Nel 1750, alla morte di Valentino, i figli Antonio e Nicolò Bergamo assegnarono alla sorella Margherita un ulteriore capitale. In seguito, Giacomo provvide ad assicurare la moglie, sebbene fosse già garantita dal defunto padre Ottavio, sulla casa alla Crosara e sui terreni a Ronc e Voltoline. Nel 1783 Giacomo ricevette dalla famiglia Bertolasi di Cles la dote paterna e materna destinata alla nuora Domenica, moglie del figlio Giovanni Battista, per un ammontare di 100 ragnesi. In cambio, egli garantì a Domenica la sicurezza della dote su un terreno a Cavauden, nel territorio di Sanzeno, e su un prato alla Pozzata.
Nel 1771 Giacomo si era occupato della vendita di una parte di casa a Segno, ereditata dalla nuora Caterina Gallo, moglie del figlio Giuseppe. L'abitazione fu alienata a Bartolomeo Isidoro Marcolla di Dardine abitante a Segno, per l'importo di 60 ragnesi. Nel 1776 Giacomo sembrava ormai vicino a concludere l’acquisto della porzione F della casa n. 3 a Dermulo, tramite un compromesso stipulato con Bartolomeo Zendron di Coredo e Leonardo Pedron di Mezzocorona, rappresentanti delle rispettive mogli, Caterina e Domenica, figlie del fu Giacomo fu Michele Inama. Per motivi ignoti, però, l’accordo non andò a buon fine. La casa, passata nel frattempo ad Antonio fu Giovanni Battista Inama e poi al genero Giovanni Mendini, fu infine acquistata dal figlio di Giacomo, Giuseppe, solo nel 1796. Nel 1781 Giacomo redasse testamento a Coredo, nello studio del notaio Giovanni Battista Rizzardi, annullando quello precedente che dichiarò di aver redatto a Brescia. Nel documento dispose diversi legati a favore delle chiese della pieve e dei vicini di Dermulo. Tra le disposizioni figurano: una carità di pane pari a cinque quarte, distribuita in tronde a chi avrebbe partecipato al funerale; una carità di sale destinata ai vicini e ai forestieri; e infine una carità di tre carantani di pane di frumento e una mossa di vino focatim per gli abitanti di Dermulo, da consegnare entro tre anni dalla sua morte. Il testatore specificò che, qualora i suoi eredi residenti a Brescia non avessero adempiuto a tali disposizioni, il parroco di Taio avrebbe potuto provvedere in loro vece, utilizzando a tale scopo la rendita del terreno situato alle Braide. Alle tre figlie lasciò 50 ragnesi ciascuna, al figlio maggiore Giuseppe il terreno a Cambiel e ai figli abitanti a Brescia, 30 ragnesi cadauno da estrarre dal fondo alle Braide. Per tutti gli altri beni nominò eredi i tre figli Giacomo, Giovanni Battista e Giuseppe. E’ del 1773 invece il testamento della moglie Margherita la quale dispose una somma di 40 ragnesi per ciascuna delle tre figlie e un'altra di 100 ragnesi ciascuno per i figli maschi. Il testamento del 1781 sembra essere l’ultimo documento in cui compare Giacomo, allora settantaduenne. Fino al 1788, anno della sua morte, infatti, si registra un silenzio documentale che lascia supporre problemi di salute tali da allontanarlo dalla vita sociale.
2.2.2.1.1. GIACOMO VII E GIOVANNI BATTISTA FIGLI DI GIACOMO III E I LORO DISCENDENTI BRESCIANI
Di Giovanni Battista si conoscono almeno tre figli, Giacomo, Maria e Giovanni Antonio. Giacomo VIII, il figlio maggiore,
tornava spesso a Dermulo insieme al padre. Nel 1800 sposò Caterina Gabrielli di Sporminore, e da quel matrimonio nacque, nel 1815,
la loro figlia Luigia, che visse fino al 1891, quando morì a Brescia. Oltre
a Luigia, Giacomo e Caterina ebbero un altro figlio, Giovanni, nato a
Fiumicello nel 1809 e rimasto legato a quella terra fino alla sua morte,
avvenuta nel 1880. Giovanni sposò Domenica Duina, e nel 1839 nacque il loro figlio
Giacomo IX, che prese in moglie Angela Reboldi. Dopo la morte di Angela,
Giacomo IX si risposò nel 1902 con Maria Tosoni. Da questi matrimoni
arrivarono diversi figli, ma solo due, Maria Domenica e Domenico Giacomo,
raggiunsero l’età adulta. Domenico Giacomo nacque a Fiumicello nel 1866 e sposò Santa
Lombardi. Da loro venne al mondo Anselmo Antonio, nato a Brescia nel 1899,
che sarà uno degli ultimi rappresentanti della linea di Giovanni Battista a
Brescia, portando avanti una storia di famiglia che si era radicata
profondamente tra valle e città.
L’ultima figlia conosciuta di Giovanni Battista fu Maria, nata nel 1791
a Fiumicello, che sposò Domenico Cavagnini. Maria morì nel 1881.
Anche
GIACOMO, nato nel 1745, era sposato e risiedeva a Brescia, nella
parrocchia dei SS. Faustino e Giovita. Non conosciamo il nome della moglie,
ma sappiamo che aveva un figlio, probabilmente il maggiore, chiamato
Giuseppe, come lo zio. Questa informazione emerge dal documento del 1804
citato in precedenza, nel quale il fratello Giovanni Battista consegnava del
denaro a Romedio Corrazzola per conto del nipote Giuseppe, “abitante alle
Chiusure di Brescia”. Possiamo quindi dedurre che, già in quell’anno,
Giacomo fosse deceduto, visto che il debito risultava a carico del figlio.
2.2.2.1.2. GIUSEPPE FIGLIO DI GIACOMO III E LA SUA DISCENDENZA A DERMULO
Giuseppe, il figlio maggiore di Giacomo, dopo l’esperienza bresciana tornò stabilmente a Dermulo e dopo la morte del padre divenne possessore della porzione E della casa alla Crosara (la porzione A e G era toccata al fratello Giovanni Battista), dell'orto (p.f. 161), e di diversi terreni fra i quali una piccola porzione del terreno alle Voltoline (p.f. 717, 718 e 719), il terreno a Sas (p.f. 51, 52, 56 e 57) gravato dalla contribuzione di mezza frachela di olio di oliva alla chiesa di Dermulo, il terreno al Bertusel (p.f. 605), i tre terreni livellari alla Tonda (p.f. 486 e 487), alla Ciaseta (p.f. 494) e una parte del terreno a Rizzai (p.f. 551 e 552) e infine due pezzeti di bosco a Cambiel (p.f. 388 e 389) e alla Pozzata (Gomer) (p.f. 469, 470 e 471). Sembra inoltre che Giuseppe avesse ricevuto dal padre come prelegato, il bosco al Plazzeg (p.f. 745), acquisito da Bartolomeo Mendini. Giuseppe nel 1762 sposò Caterina Gallo, figlia di Tomaso di Segno, dalla quale nel 1773 ebbe un figlio, chiamato anch’egli Giacomo. A Brescia nacquero inoltre due figlie, dei cui nomi non si conserva memoria, ma che furono beneficiate nel testamento di Giacomo Antonio Inama, di una somma di 8 ragnesi ciascuna. Rimasto vedovo, nel 1803 Giuseppe contrasse un nuovo matrimonio con Caterina de Micheli di Maiano, dalla quale ebbe un’unica figlia, di nome Felicita. Rimasta a sua volta vedova, Caterina sposò in seconde nozze Pietro Marinelli di Vervò. Giuseppe, che morì l’11 aprile 1810, un anno prima svolgeva ancora la funzione di sacrestano nella chiesa di Dermulo e nel 1802 ne aveva ricoperto anche la carica di sindaco. Già nel 1781 compare in un’adunanza di regola come rappresentante di Giacomo Antonio Inama di Taio: in quegli anni, infatti, era livellario dei beni che quest’ultimo possedeva a Dermulo e che in precedenza erano stati affittati al padre Giacomo. Nel 1796 Giuseppe acquistava,
per la somma di 215 Ràgnesi, da Giovanni
Mendini una parte di
casa alla Crosara
(porzione F)
confinante con la sua e in passato appartenuta a
Giacomo fu Michele Inama.
Giacomo, unico figlio maschio di Giuseppe, nacque nel 1773 e nel 1795 sposò Brigida Inama, figlia di Giovanni della linea soprannominata Battistei. Dal matrimonio nacquero sei figli, ma quattro morirono in tenera età; due invece, Giovanni (1804) e Giacomo (1815), lasciarono una numerosa discendenza. Alla morte del padre,
avvenuta nel 1810, Giacomo divenne proprietario di gran parte della
casa alla Crosara
(porzioni
E,
F e
G). In quell’anno,
alla presenza degli altri comproprietari, Baldassarre
Inama e
Matteo Mendini, venne regolamentato per
iscritto l’uso del somasso comune e
di quello gravato da diritti di passo. Poco prima Giacomo aveva ceduto una
parte di tale somasso al Mendini.
Già nel 1806 egli aveva acquistato da Matteo Mendini, per 150 ragnesi, un
prato alla Mora (p.f. 569) e, poco
dopo, l’utile dominio del prato della chiesa a
Poz (p.f.
216 e
217), dallo zio Giovanni Battista.
Negli anni successivi arricchì ulteriormente il proprio patrimonio: Nello stesso 1817 Elisabetta
vedova di Giovanni Battista Inama gli vendette altri tre terreni: un fondo
alle Marzole (p.f. 293), un
arativo al Gomer (p.f. 468?) e un
gregivo a Cambiel. Sempre alle
Marzole, nel 1801, la moglie Brigida era già entrata in possesso di un terreno (p.f.
292) del padre Giovanni, dopo un accomodamento con la sorella Anna. Oltre che coltivare i suoi terreni, Giacomo nel 1822 ricoprì la mansione di cursore per il comune di Dermulo. Il 4 dicembre 1824 redasse testamento, nominando eredi universali i due figli Giovanni e Giacomo, e disponendo per la moglie Brigida l’usufrutto “della stufa e cucina, il letto con tre paia di lenzuola e coperta de petoloti a rigoni”, nonché di vari terreni: alle Marzole (p.f. 292 - p.f. 293), al Plantadiz (p.f. 264), alla Mora (p.f. 569) e il prato a Sas (p.f. 56 e 57). I figli avrebbero dovuto farsi carico dei livelli e degli oneri gravanti su tali beni. Giacomo morì l’anno successivo, mentre Brigida gli sopravvisse fino al 1843. Nel 1841, non sapendo
scrivere, Brigida firmò con una croce il proprio testamento, redatto da don
Giacomo Mendini in presenza di Romedio Emer e Romedio Mendini. Nello
scritto, lasciò alcuni
effetti personali alla nipote Brigida (figlia di Giovanni) e alla nuora
Maria, moglie del figlio Giacomo; allo stesso Giacomo assegnò “un lavezzo di
bronzo e un lenzuolo con le frange rosse”. Tutti gli altri beni mobili e
immobili furono divisi tra i figli Giacomo e Giovanni. Nel 1834 i due fratelli divisero formalmente il patrimonio paterno. Le proprietà, le passività e i beni mobili furono ripartiti in due porzioni estratte a sorte: Giovanni ricevette la porzione numero uno, comprendente la casa posta a mattina, mentre Giacomo la porzione numero due con la casa posta a sera. Poiché Giacomo era ancora minorenne, fu assistito dalla madre Brigida e da Baldassarre Inama. (Documento di divisione). Nel 1842 i fratelli
acquistarono dai minori figli del fu Nicolò Valentini di Tassullo un prato
con bosco alle Forche (probabilmente segnato dalle future p.f. 1517-1518)
nel comune catastale di Coredo, a nord del
rio delle Forche. Per il
pagamento si accollarono un debito di 300 fiorini verso Francesco fu Antonio
Moggio di Cles, garantito con ipoteca sul fondo stesso e sul prato ai
Visenzi.
2.2.2.1.2.1. GIOVANNI FIGLIO DI GIACOMO E LA SUA DISCENDENZA V. Lista n. 4
Giovanni, detto Sèp, era nato nel 1804 e si era sposato con Caterina Mendini di Taio nel 1826. Egli visse con la famiglia nella porzione E della casa alla Crosara che gli era toccata nelle divisioni con il fratello Giacomo. Nel 1830 Giovanni vinse l'appalto per la fabbricazione del pane per il paese di Dermulo, incarico che espletò fino al 1832. Nelle divisioni con il fratello gli erano toccati la porzione a mattina del terreno a Sas (p.f. 52, e 57), arativo vignato alle Bertuse (p.f. 307-308), una porzione del terreno e bosco a Cambiel (p.f. 388 e 392), un arativo a Cavauden sul territorio di Sanzeno (p.f. 603), la metà del prato ai Visenzi (p.f. 595), l'arativo al Gomer (p.f. 468), la metà a sud del bosco a Cavauden (p.f. 1521 e 1522), la metà a mattina del bosco a Cambiel (p.f. 388 e 389) e il bosco al Plazzeg (p.f. 745). A Giovanni erano pervenuti anche alcuni terreni livellari, ossia una porzione del fondo a Rizzai (p.f. 551-552), la metà dell'orto agli Orti (p.f. 161), l'arativo alla Tonda (p.f. 487), e il prato alla Ciaseta (p.f. 494). Dopo la morte della madre Brigida, Giovanni venne in possesso anche dei terreni da lei detenuti in usufrutto, ovvero alle Marzole p.f. 293, (escluso quello suo dotale p.f. 294, toccato al fratello Giacomo), metà del luogo al Plantadiz p.f. 264/1, e il prato alla Mora (p.f. 569). Nel 1840 comperava per la somma di 164 fiorini, un terreno al Raut (p.f. 623) da Luigi Mendini. Nel 1844 Giovanni era bisognoso di denaro per cui il dottor Pietro Oliari di Tiarno Superiore, medico condotto a Coredo, gli prestava la somma di 200 fiorini abusivi, pari a 168 fiorini austriaci. L'Oliari gli consegnò fisicamente 11 sovrane d’oro per fiorini abusivi 17X30 cadauna e 3 napoleoni d’argento per fiorini abusivi 2X30 cadauna, da restitire entro 3 anni all’interesse del 5% annuo. Il capitale fu assicurato sui seguenti beni: arativo vignato con gelsi e altri alberi alla Bertuse, arativo pertinenze di Sanzeno a Cavauden, arativo vignato a Sas e sull'arativo al Raut. Nel 1855, l’anno della tristemente famosa epidemia di colera, Giovanni ricopriva la carica di capocomune e in tale veste dovette affrontare l’emergenza, restandone però anche lui vittima. Infatti si contagiò e morì il 17 settembre 1855, seguito due giorni dopo dalla moglie Caterina Mendini. Il contagio era evidentemente presente nella casa tanto che morì pure la cognata Maria moglie di Giacomo. Nell'archivio comunale è presente una lettera che l'allora medico condotto di Taio, dottor Danieli, spedì a Giovanni, quale capo comune di Dermulo. Nella lettera datata 13 settembre, il medico impartiva delle indicazioni di comportamento e di vigilanza sulla casa di Giacomo, fratello di Giovanni. Tali suggerimenti non arrivarono sicuramente in tempo perchè Giovanni aveva già contratto il morbo e stava per morire. Dopo la morte dei genitori, rimasero superstiti a Dermulo i due figli Filomena ed Eugenio, quest'ultimo appena tredicenne. Filomena si sposò l’anno seguente con Giovanni Depero di Quetta. In quest'ultimo villaggio si era già trasferita dopo il matrimonio con Giovanni Noldin, la sorella maggiore Luigia e quindi Eugenio rimasto solo, si affidò alla sorella Brigida maritata a Dermulo con Giuseppe Inama. Un aneddoto tramandato in famiglia e riportatomi da mia zia Maria, riguardava il luogo della casa ai Rodari, dove il ragazzo Eugenio trascorse i suoi primi anni da orfano. Si dice che la sorella Brigida lo avesse sistemato per la notte, in un locale semi aperto, soggetto a spifferi e correnti d'aria, dove la sua coperta era costituita da foglie secche di granoturco con sopra appoggiata una porta di legno, per evitare che queste volassero via. Nel maggio del 1858 davanti a
Lorenzo Inama capocomune di Dermulo, fu presentato un progetto divisionale
della sostanza abbandonata da Giovanni che nel testamento aveva eletto erede
Eugenio, assegnando la legittima alle figlie Luigia, Filomena e Brigida.
Alla divisione ereditaria parteciparono Battista Mendini zio e tutore dei
minori Luigia e Eugenio e le altre due figlie cioè Filomena e Brigida.
L’inventario era stato redatto il 12 dicembre 1855 ma nel frattempo si erano
aggiunti alcuni crediti, quali 65 fiorini per
carreggi fatti per conto dell'impresa di Valentino Bosin,
costruttore della nuova strada di Concorrenza, nel tratto fra Taio
e Sanzeno. Altri 100 fiorini erano da conteggiare per la vendita di due buoi
e 183 fiorini per la mobilia consegnata a Brigida in occasione del suo
matrimonio. Venne redatto quindi lo stato attivo e passivo e fu concordato
di fare la divisione non a sorteggio ma per assegnazione. Ad Eugenio si
assegnarono,
nove camicie, quattro lenzuola, due manipoli, due sugamani, sette
mezzalana, un vestito di pano, un corto di pano, braghe e gilè, un capello,
due paioli di rame, una catena da fuoco e trepiedi, una cazza dall’acqua e
triangolo, una banca, una cassa di noce e una cassetta di pezzo, una botte,
due boticelli e una castelata, tre banchi del grano della tenuta di St. 50,
un centonaro dall’olio, un orologio da scarsela, un pico e un badile, una
bena calce, tela canevela per abiti. Riguardo ai terreni Eugenio
ricevette l'arativo al Raut (p.f. 623),
l'arativo a Cavauden di sotto
la strada (p.f. 603), il
prato, arativo e bosco a Cavauden
sul tenere di Coredo (p.f. 1521 e 1522), l'arativo alle
Marzole (p.f.
293), il prato ai Visenzi (p.f.
595), il prato a Poz (p.f. 216),
l'orto (p.f. 161) ed infine
la casa
(porzioni
E, e
G) con cortile.
EUGENIO
raggiunta la maggiore età, nel 1863 sposò Giuseppina Pilati di Tassullo,
dalla quale ebbe cinque figli: Maria, Rachele, Annibale, Filomena e Celeste.
Dalla ripartizione ereditaria, considerata l’importanza della terra quale
principale fonte di sostentamento familiare, emerge che Eugenio non godette
di particolari privilegi. Le sorelle, infatti, si spartirono un numero
consistente di terreni paterni, che in seguito vennero alienati e uscirono
dal patrimonio della famiglia Inama. Eugenio durante la sua vita occupò con
la famiglia la porzione di casa
E, e
G ereditata dal
padre. Nel 1875 contrasse un debito di 100 con Massimo Gebelin di Cles,
sottoponendo a ipoteca la casa e il vignato a
Risola (p.f.
780),
a)
Annibale
nacque nel 1868 e nel 1898 sposò Angelica Menapace di Rallo. La sua
infanzia, come quella dei suoi coetanei, fu segnata presto dal lavoro: nel
1880 il padre Eugenio stipulò con il comune di Dermulo un
contratto per il pascolo delle
capre, attività alla quale fu destinato Annibale quando aveva appena dodici
anni. La sua strada si incrociò con quella di Angelica a Taio. Lei lavorava
come inserviente nella casa dei Chilovi, detti Ciapelani,
b)
Celeste
nato nel 1873, nel 1901 sposò Fortunata Inama,
figlia di Filippo, e andò ad abitare con lei nella porzione
C della
casa n. 2, acquistata due anni prima da Mansueta Inama. Dal loro
matrimonio nacquero Nel 1921, alla morte del padre Eugenio, l’eredità e i beni da lui lasciati furono divisi tra Celeste e il nipote Alessandro, figlio del fratello premorto Annibale. Quattro anni più tardi, nel 1925, Celeste iniziò la costruzione di una nuova casa sui mappali 3-4, anch’essi ereditati dal padre assieme alle p.f. e 788-789. L’abitazione, contraddistinta dal numero civico 46, venne in seguito abitata dai figli Bruno e Marino. Oggi (2025) appartiene in parte ad Adriano Inama, figlio di Bruno, e in parte a un’altra famiglia. Nelle divisioni a Celeste
furono assegnati la
casa n. 2 con l'orto della
casa n. 3,
(p.f. 161) la parte a est del
vignato al Campolongo (p.f. 826/2),
il terreno vignato a Somager (p.f. 3-4,
788-789), il greggio e pascolo a Risola
(p.f.
780), una parte del prato a Poz (p.f.
216 e 217), una parte del
campo alle Marzole (p.f. 293), il
campo al Raut (p.f. 623), la parte
a nord del greggio e bosco a
Cavauden pertinenze di Coredo (p.f. 1522 e 1523), la parte a est del
campo al Raut
(p.f. 619. 620 e 621) e metà del bosco ai
Fossadi (p.f.
501, 502). Dal 1922 al 1925 Celeste ricorprì l'incarico di sindaco del
Comune di Dermulo, mentre nel 1926, fu delegato a rappresentare il comune
dal podestà di Taio. Celeste morì nel 1935, dieci anni prima della tragica
scomparsa della moglie Fortunata. Il 3 maggio 1945, un gruppo di sedicenti
partigiani appostati nei boschi sopra Dermulo aprì il fuoco contro un
capitano tedesco, responsabile del deposito militare che si trovava non
lontano dall’abitazione di Fortunata. Si racconta che la donna, uscita di
casa per prestare soccorso al soldato ferito, venne a sua volta colpita da
una raffica di mitra che le fu fatale. Oggi, accanto alla porta d’ingresso
della casa di Adriano Inama, una mattonella dipinta ricorda quel tragico
episodio. (poesia di Ida
Seppi)
c) le sorelle Maria, Rachele e Filomena sposarono rispettivamente Edoardo Mendini di Taio, Giuseppe Devigili di Mezzolombardo e Beniamino Inama di Dermulo.
2.2.2.1.2.2. GIACOMO FIGLIO DI GIACOMO E LA SUA DISCENDENZA V. Lista n. 5
Giacomo detto Sep, nato nel 1815, era il fratello più giovane di Giovanni e occupava la parte di casa n. 3 che fino agli anni Settanta del Novecento fu di Elisabetta Inama, detta Liseta. Nelle divisioni dei beni effettuate nel 1834 con il fratello, oltre alla casa casa n. 3 (Porzione E) gli erano toccati i seguenti beni: il terreno a Sas (p.f. 51, e 56), il terreno al Bertusel (p.f. 605), l'arativo a Cambiel (p.f. 389), il prato ai Visenzi (p.f. 594), metà del prato al Gomer (p.f. 469 470 471), la metà a settentrione del bosco a Cavauden (p.f. 1521 e 1522), la metà del bosco a Cambiel (p.f. 393). Inoltre dei terreni soggetti a livello, l'arativo a Rizzai (p.f. 551 e 552), l'orto agli Orti (p.f. 162), la porzione a mattina dell'arativo alla Tonda (p.f. 486), metà dell'arativo e prativo alla Ciaseta (p.f. 494), e la porzione a settentrione del prato a Poz (p.f. 217). Dopo la morte della madre Brigida venne in possesso del di lei terreno dotale alle Marzole (p.f. 294) e di metà terreno al Plantadiz p.f. 264/2. Al piano terra della casa
lungo la vecchia via imperiale, nel 1852 Giacomo aprì una bettola, che passò
per un periodo in gestione al figlio Ferdinando. L’attività, però, si rivelò
fonte di difficoltà: proprio a causa della bettola, Giacomo contrasse un
debito di 300 fiorini con Giovanni Lodovico Fellin, geometra di Cles che gli
aveva fornito il vino. Nel 1853, per garantire il credito, furono ipotecati
i suoi terreni a Cambiel,
Rizzai,
Plantadiz,
Marzole,
Sas,
Bertusel e
Tonda.
La situazione finanziaria peggiorò rapidamente. Per un ulteriore debito di
80 fiorini nei confronti di Vittore fu Pietro Chistè, nel 1859 fu ipotecata
anche la
casa n. 3, insieme a un fondo
prativo e boschivo a Cavauden
(p.f. 1522, 1523, 1517, 1518), oltre a campi arativi a
Rizzai,
Bertus e
Marzole. A metà degli anni Sessanta dell’Ottocento, i debiti divennero
sempre più gravosi e Giacomo fu costretto a vendere il prato a
Poz a Lorenzo
Eccher. Giacomo si sposò una prima volta nel 1840 con Maria Inama, figlia di Baldassarre Rodar, dalla quale ebbe due figli: Camillo e Serafina. Maria morì nel 1855, vittima del colera, e l’anno successivo Giacomo sposò in seconde nozze Anna Chini di Taio. Da questo matrimonio nacquero Desiderato, Arcangelo, Ferdinando, Costanza e Rachele. Giacomo morì nel 1889 lasciando un patrimonio di 598,57 fiorini. Con testamento designò erede principale il figlio Arcangelo, terzogenito del secondo letto, riservando agli altri figli – Serafina, Rachele, Costanza, Camillo e Desiderato – soltanto la quota legittima. Alla vedova Anna spettò l’usufrutto su tutti i beni, con l’eccezione della parte spettante a Desiderato. Il patrimonio comprendeva gli immobili scampati all’asta: la casa n. 3, l’orto (p.f. 162), il prato detto alla Busa o Pra Comune (già chiamato Gomer, p.f. 469 470 471) e l’arativo a Cavauden (p.f. 1517, 1518), pertinenze di Coredo. A questi si aggiungevano i terreni acquistati nel 1871: l’arativo al Raut (p.f. 630 631 632) e il vigneto alle Voltoline (p.f. 681, 682, 683 e 684). Camillo e Serafina, moglie di Matteo Pichler, ricevettero a saldo dell’eredità paterna 109 fiorini. L’erede Arcangelo dovette però farsi carico anche delle passività, tra cui un debito di 365,12 fiorini nei confronti del Beneficio primissariale di Dermulo, per il quale furono ipotecati gli immobili ricevuti. È probabile che Giacomo abbia privilegiato Arcangelo perché fu l’unico dei figli a rimanere accanto al padre dopo la vedovanza, condividendo con lui la casa paterna. Camillo, il primogenito, era già sposato e viveva al Borgo; Desiderato e Ferdinando si erano allontanati presto da Dermulo: il primo morì in Germania nel 1882, il secondo in Svizzera dieci anni prima della morte del padre.
a)
Camillo,
nato nel 1840, lasciò la casa paterna
per trasferirsi nella
n. 14 in occasione del suo
matrimonio, celebrato nel 1867 con eresa
Elisabetta Inama, figlia di Giovanni Battista. Dalla famiglia della
moglie ereditò il soprannome Battistel,
mentre i suoi disc Rimasto vedovo nel 1882, Camillo sposò l’anno successivo Teresa Corrà di Revò. Il figlio maggiore Amadio nel 1902 sposò Rosa Stratta di Taio ed ebbero sei figli, Elisabetta, Severino, Amedeo, Eligia, Alberto e Romeo. Quest’ultimo, il più giovane tra i maschi, rimase a Dermulo, dove sposò Fiorentina Emer e abitò nella casa paterna. Giovanni Battista, il figlio più giovane di Camillo, nel 1910 sposò Carlotta Mendini di Taio: da loro nacquero Dario, Rita e Giulio. Dario, con la moglie Valeria Sandri, rimase nella casa n. 14, mentre Giulio visse a Taio. Un altro figlio di Camillo,
Luigi (n. 1870), sposò nel 1898 Domenica Zambiasi di Cagnò. Due anni
più tardi nacque il loro primogenito, Luigi Camillo, e nello
Ogni anno, a luglio, la famiglia si riunisce per celebrare e ricordare le proprie origini (vedi poster di famiglia). Negli anni Novanta del Novecento entrai in contatto via e-mail con Lewis Enama, figlio di Luigi Camillo, il primogenito e unico nato in Italia. Dopo anni di corrispondenza, nel 2012 Lewis giunse finalmente in Italia con la moglie, la figlia e il genero per visitare i luoghi delle sue radici. Tornò ancora nel 2018, questa volta con un numeroso gruppo di familiari. Negli anni successivi altri discendenti di Luigi arrivarono a Dermulo, desiderosi di vedere i luoghi dei loro avi, in particolare la vecchia chiesetta e la casa natale di Luigi. (vedi poster della famiglia di Leonard Enama).
b) Desiderato nato nel 1859, lasciò presto Dermulo, dove nel 1894 risultava già indicato come “di ignota dimora”. Nel 1899, mentre dichiarava di aver soggiornato a Waldshut (Baden), presentò al Comune di Dermulo richiesta di passaporto, affermando di trovarsi incarcerato a Zurigo. Nel 1905 richiese invece un certificato necessario per esercitare un’attività “industriale” a Waldshut, località in cui con ogni probabilità morì celibe nel 1922. Un documento reperito sul web chiarisce le circostanze della sua detenzione a Zurigo: la falsificazione di documenti. Dagli atti processuali emerge che Desiderato aveva vissuto nel Canton Zurigo insieme a Josephine Schärer, nata nel 1857 a Mussbach (Granducato di Baden) e residente fino al 1899 a Kreuz-Stäfa, nei pressi di Zurigo. Josephine, detenuta nel 1899 nel carcere cantonale, era sposata con Andreas Reinbold, capostazione a Mussbach, dal quale si era allontanata dopo aver avuto un figlio nel 1885, a causa di ripetuti abusi e maltrattamenti. Dopo la fuga intrecciò una relazione clandestina con Desiderato, probabilmente operaio nel Canton Zurigo vicino al confine tedesco. Dal loro legame nacquero quattro figli: Caroline nel 1888 a Horgen, Louise nel 1892 a Zurigo, Joseph nel 1896 a Männedorf, e infine, Charles Augustus nel 1899 a Zurigo. I bambini furono registrati come legittimi figli di Andreas Reinbold, poiché Desiderato si era finto suo marito: proprio questa falsificazione costituì uno dei capi di imputazione. Addirittura Charles Augustus fu concepito durante il processo, in violazione dell’ordine ufficiale di interrompere la convivenza. La verità emerse quando la coppia, come spesso accadeva in quel periodo, si rivolse alla parrocchia di Stäfa per chiedere un sussidio. Il parroco, prima di concederlo, avviò delle verifiche tramite l’ufficio distrettuale di Baden-Emmendingen, che accertò la situazione e informò a sua volta l’ufficio distrettuale di Meilen. Quest’ultimo avviò un’indagine penale, e il 23 marzo 1899 il pubblico ministero presentò formale accusa per ripetuta falsificazione dello stato civile. Entrambi gli imputati furono riconosciuti colpevoli: Josephine venne condannata a sei mesi di lavoro (al netto di cinque settimane già scontate in detenzione preventiva) e all’espulsione dalla Svizzera per dieci anni. La stessa pena fu inflitta a Desiderato, con in aggiunta dieci giorni di carcere e una multa di 35 franchi. Un successivo ricorso sembra essersi concluso in maniera favorevole alla coppia, che probabilmente, dopo la scarcerazione, si stabilì insieme a Waldshut. Qui infatti nel 1905 è attestata la presenza di Desiderato. [61]
c) Arcangelo detto Todes-c, nacque nel 1861 da Anna, seconda moglie di Giacomo. Il soprannome rivela un periodo giovanile trascorso in un paese di lingua tedesca, come già accadde ai fratelli Desiderato e Ferdinando. A differenza di questi ultimi, Arcangelo fece però ritorno stabilmente a Dermulo, dove nel 1891 sposò Addolorata Endrizzi. La coppia abitò nella casa n. 3, ma ebbe solo un figlio, morto subito dopo la nascita. Decisero allora di adottare la pronipote Elisabetta, figlia di Amadio. Nel 1894 la famiglia si prese cura dell’anziano Giovanni Endrizzi detto "Bambin", figlio del fu Mattia, ricevendo dal comune di Dermulo un compenso di 40 fiorini. È probabile che l’assistenza fosse durata fino al 1907, anno della morte di Giovanni. Nel 1914 Arcangelo e Addolorata risultano invece custodi di Giovanni Pircher, figlio illegittimo di Maria Pircher di Parcines. Giovanni viveva a Dermulo almeno dal 1852, ospite nella casa di Giovanni Battista Inama. Divenuto adulto, aveva sposato Maria Rosetti di Taio e lì si era trasferito. Nel 1876 rimase cieco a causa dello scoppio di una mina e, in quanto pertinente di Dermulo, ricevette per anni un sussidio comunale. Malatosi nel 1909, non fu più in grado di vivere autonomamente e venne affidato ad Arcangelo e Addolorata. Tra il 1909 e il 1911 Arcangelo ricoprì l’incarico di guardia boschiva comunale. Nel frattempo, Elisabetta apprese dalla zia Addolorata l’arte del cucito. Alla morte dei genitori adottivi ereditò la casa n. 3, il vigneto alle Voltoline (p.f. 681, 682, 683 e 684) e l’orto (p.f. 162). Non è chiaro se gli altri terreni di Arcangelo (alla Busa, a Cavauden e al Raut), registrati a suo nome agli inizi del Novecento, fossero stati venduti da lui o dai suoi eredi. Elisabetta visse con il marito Giulio Bertagnolli al secondo piano della casa. Dal matrimonio nacque una figlia, Norina detta Nori, che sposò Gianni Plazio di Caluso, in Piemonte. Negli ultimi anni Elisabetta si trasferì presso la figlia, dove morì negli anni Ottanta del Novecento.
d) Ferdinando che era nato nel 1857, ebbe una vita molto breve, per cui si hanno pochissime notizie. Era poco più di un ragazzino quando durante l’inverno si recava in Piemonte, Liguria e Lombardia (nei così detti "Paesi Sardi") per fare lo spazzacamino. Per qualche tempo gestì la bettola assieme al padre ma nel 1879, quando si trovava nel Cantone Uri in Svizzera, morì improvvisamente a soli 22 anni. Da un documento presente nell'archivio dell'ex comune di Dermulo, si dice che Ferdinando fosse bersagliere provinciale dell'esercito austro-ungarico. Forse la sua presenza in Svizzera era dovuta alla chiamata del fratello Desiderato.
e) le sorelle Serafina, Costanza e Rachele sposeranno rispettivamente Matteo Pichler di Mezzolombardo, Domenico Brugnara di Faedo ed il vedovo Germano Emer di Dermulo.
2.2.2.2. SILVESTRO FIGLIO DI OTTAVIO
Silvestro nacque nel 1712 e
nel 1748 sposò Maria Domenica Widmann di Salter. L’Inama-Sternegg sostiene
invece – probabilmente per errore, a meno che non si trattasse di una prima
moglie – che il cognome di Domenica fosse Covi. A chiarire il dubbio non
aiuta il registro dei matrimoni conservato nella canonica di Taio: pur
riportando la data della celebrazione (17 agosto 1748) e il nome completo
dello sposo, il compilatore omise infatti il cognome della sposa. La
conferma che Domenica appartenesse alla famiglia Widmann proviene però da un atto
notarile del 1750, relativo a una controversia tra Silvestro, quale marito
di Maria Domenica fu Antonio Widmann di Salter, e il cognato Bonifacio
Widmann. Dopo due anni dal matrimonio, infatti, Domenica non aveva ancora
ricevuto la dote paterna. L’accordo stabilì che Bonifacio dovesse versare
entro tre anni dodici ragnesi, metà in grano interzato alla tassa e metà in
bestiame. Nel 1752 Silvestro acquistò dal cugino Giovanni Giacomo Inama di Taio,
alcuni terreni gravati da livelli che quest’ultimo desiderava alienare.
L’operazione riguardava: un appezzamento "arativo e vignato con due
stregle", situato alle Pontare (detto anche
Cambiel) e soggetto a livello
dei Lucchi di Sarnonico; un campo arativo e vignato contiguo, anch’esso a
Cambiel, gravato da un livello nei confronti di Antonio Bertolini di Cles,
per tre stari di frumento; e infine un altro campo arativo e vignato alle
Bertuse, pure livello Bertolini, per quattro stari di frumento. Con
l’acquisto, Silvestro si accollò l’obbligo di versare annualmente cinque
stari di frumento e due di segale, che doveva consegnare a proprie spese
presso l'abitazione dei Bertolini a Cles, oltre a pagare 50 ragnesi a
Giuseppe Lucchi. Nel 1767 Silvestro ottenne in locazione temporale, per la
durata di nove anni, due fondi a Dermulo situati a Cambiel di Sotto e a
Cambiel di Sopra, concessigli da Romedio Maria Mendini. In base al
contratto, egli si impegnava a corrispondere ogni anno, a San Michele,
quattro stari di grano “netto e ben stagionato”. Tra il 1766 e il 1768
Silvestro ricoprì la carica di
regolano della comunità
di Dermulo, in parte condivisa con il fratello
Giacomo. Proprio nel 1766, in
tale veste, partecipò alla stesura dell’inventario
dei beni primissariali, redatto su ordine delle autorità superiori. Alla
morte del padre Ottavio, Silvestro ereditò la porzione B della
casa alla Crosara. Nel 1757, però, fu costretto a cedere a Giacomo
Mendini la metà di una cantina situata in quella stessa porzione, per
saldare un debito di 30 ragnesi contratto dal padre. Dieci anni più tardi,
nel 1767, Silvestro riuscì a riottenere la proprietà, riacquistandola da
Romedio Maria Mendini, figlio di Giacomo. Nel 1769 Silvestro acquistò da
Lucia Endrizzi un orto nei pressi della sua abitazione (p.f.
158) sul quale gravava un canone annuo di sei troni a favore della
primissaria di Dermulo. L'onere fu assunto da Silvestro che avrebbe versato
l'importo, metà in grano e metà in denaro.
Baldassarre fu l’unico erede di Silvestro e alla morte del padre ne
raccolse l’intero patrimonio che però non sembra essere stato molto
cospicuo. Gli spettò innanzitutto la porzione B della
casa n. 2, sulla quale nel 1777
garantì un prestito di 50 ragnesi ottenuto dallo zio Giacomo. (La facoltà di
esigere il debito fu poi trasferita nel 1781 da Giacomo, ai fratelli Antonio
e don Gaspare Chilovi di Taio) Nel 1788, sempre sulla stessa casa e in
particolare su una stalla, contrasse un nuovo prestito di 53 ragnesi, questa
volta con Leonardo Desiderati di Coredo, con ulteriore garanzia prestata
dallo zio Giacomo. Baldassarre, oltre alla casa e a un orto di notevoli dimensioni – oggi riconducibile alle particelle fondiarie 158, 159 e 160 – disponeva anche di un terreno a Cambiel (p.f. 376). Nel corso della vita riuscì ad ampliare il proprio patrimonio fondiario, tanto che nell'anno della sua morte possedeva diversi campi acquisiti progressivamente negli anni. Alcuni terreni gli furono concessi in locazione perpetua, una forma di possesso molto diffusa all’epoca. Tra questi figurano i campi alla Cros (p.f. 315, 316 e 317), ricevuti dalla chiesa di Dermulo nel 1788; un terreno a Cambiel (p.f. 375), proprietà di Romedio Maria Mendini; e un fondo alle Late (p.f. 640), che la comunità di Dermulo gli affidò nel 1798. Anche il terreno al Gomer (p.f. 462, 463 e 467) gli fu inizialmente dato in semplice locazione nel 1805, per nove anni, dal conte Matteo Thun, ma in seguito la concessione venne trasformata in perpetua, garantendo così una stabilità maggiore. Importanti furono anche le acquisizioni per donazione e acquisto. Nel 1782 Baldassarre venne infatti beneficiato dal testamento di Giacomo Antonio Inama di Taio, che gli lasciò un terreno al Cambielot (p.f. 377, 383, 386, 387, 384 e 385). Sempre nello stesso anno acquistò da Bartolomeo Mendini un arativo vignato alle Voltoline (p.f. 708, 709, 710 e 711). Più tardi, nel 1788, comprò da Leonardo Desiderati di Coredo l'utile dominio di un fondo gafforiale a Ronc (p.f. 653) e, infine, nel 1803 da Anna Inama un appezzamento a Rizzai (p.f. 555, 556, 557 e 558). Baldassarre nel 1790 cedette il terreno gafforiale a Domenico Massenza. Giacomo Antonio Inama, oltre al sopra menzionato terreno, gli lasciò pure il diretto dominio su un altro campo a Cambiel: ciò gli consentì di esigere un canone annuo di 5 ragnesi dall’affittuario che lo deteneva in locazione perpetua. Successivamente, con un codicillo del 1782, Giacomo Antonio gli destinò anche la metà di un credito che vantava verso Giacomo Endrizzi di Dermulo. Nel 1781, per estinguere il debito di 50 ragnesi verso i fratelli Chilovi, Baldassarre cedette loro una parte del terreno ereditato al Cambielot; nello stesso atto, i Chilovi glielo concessero nuovamente in locazione perpetua. Baldassarre, oltre a dedicarsi alla coltivazione dei campi, esercitava anche l’attività di tessitore, che gli garantì un certo miglioramento economico. Nel 1766 sposò Maria Maddalena Dallavo, figlia di Valentino di Revò, dalla quale ebbe sette figli. Nel 1780 fu nominato saltaro, mentre negli anni 1789 e 1790 ricoprì la carica di regolano della comunità, insieme a Giovanni, figlio del fu Giovanni Battista Inama. Baldassarre si spense a Dermulo nel 1822, seguito l’anno dopo dalla moglie Maria. Dei loro sette figli, solo Silvestro e Valentino raggiunsero l’età adulta e furono loro a raccogliere l’eredità di famiglia. Le loro vicende saranno raccontate nei paragrafi che seguono.
2.2.2.2.1. SILVESTRO FIGLIO DI BALDASSARRE (V. Lista n. 6)
Silvestro nacque nel 1778 e nel 1810 sposò Orsola Menapace di Tassullo, dalla quale ebbe due figli, Baldassarre e Giacomo. Alla morte del padre, avvenuta nel 1822, ereditò la porzione B della casa n. 2 con il vicino orto (p.f. 159 e 160). Nel 1825 dovette sottoporre a ipoteca un fondo a Cambiel (p.f. 384 e 385) per garantire il pagamento delle messe legatarie dovute alla chiesa di Dermulo, poiché non aveva provveduto ai versamenti per alcuni anni, accumulando così un debito di 61 fiorini e 36 carantani. Cinque anni dopo, un nuovo debito verso la stessa chiesa, questa volta di 87 fiorini e 42 carantani, lo costrinse a ipotecare un altro fondo a Cambiel (p.f. 376) insieme a un terreno a Rizzai (p.f. 555, 556). Nel 1844, assieme al nipote Lorenzo Inama, Silvestro riuscì ad affrancarsi dal livello sul terreno al Gomer (p.f. 462, 463 e 467), pagando al conte Leopoldo Thun 50 fiorini. Nello stesso periodo cedette inoltre una parte dell’orto (p.f. 159) a Giacomo Endriocher. Faceva parte del suo patrimonio anche una porzione del terreno alle Voltoline (p.f. 710 e 711), posseduto a livello dalla primissaria, mentre l’altra parte spettava al fratello Valentino.
a) BALDASSARRE, nato nel 1815, nel 1841 sposò Domenica Tamè, figlia di Vittore. Con le nozze lasciò la casa paterna (porzione B della casa n. 2) per trasferirsi nella casa n. 25, di proprietà dei Widmann, dove il suocero era colono. Dal matrimonio nacquero tre figli: Eugenia, Filippo e Agostino Faustino Bonifacio Pacifico, chiamato comunemente Agostino, ma a volte anche Pacifico. Alla morte di Vittore Tamè, Baldassarre rimase l’unico manente della famiglia Widmann e si occupò della gestione dei numerosi terreni del maso, oltre a quelli ereditati dal padre: l’orto agli Orti (p.f. 160), l’arativo, pascolo e bosco alla Cros (p.f. 315 e 316), l’arativo a Cambiel (p.f. 386 e 387), il prato a Rizzai(p.f. 555, 556) e il terreno alle Voltoline (p.f. 708, 710 e 711). Nel corso degli anni seppe inoltre accrescere il patrimonio con nuove acquisizioni: dopo il 1830 acquistò dagli eredi di Pietro Emer l’arativo alla Pinza (p.f. 359 e 360) e, nel 1876, da Eugenio Inama il prato ai Visenzi (p.f. 595) per la somma di 220 fiorini. Baldassarre morì l’11 dicembre 1890. Nel testamento, redatto a Vervò nel 1888, nominò eredi universali i figli Filippo e Agostino, destinando a Eugenia la quota legittima, corrispondente al terreno a Cambiel (p.f. 386 e 387). Stabilì inoltre che, qualora la figlia fosse rimasta nubile — come poi avvenne — le sarebbe spettato l’usufrutto sull’arativo alla Cros (p.f. 315 e 316) e sulla casa paterna. Nel documento precisò anche che, se per qualsiasi motivo Agostino o Filippo, o entrambi, avessero abbandonato la casa e il maso Widmann di cui erano mezzadri, avrebbero avuto diritto ad abitare la casa e a utilizzare la cucina comune. In tale eventualità, Eugenia avrebbe dovuto ospitare nella propria camera le figlie di Agostino. Nel 1887 Filippo e Agostino acquistarono da Battista Cescati di Taio un ampio prato ai Visenzi, contraddistinto dai mappali 596 e 597, per la somma di 400 fiorini. Il terreno confinava a sud con quello già di proprietà del padre Baldassarre (p.f. 595). Nel 1893 don Domenico Tamè nel testamento beneficiò i nipoti Filippo, Agostino e Eugenia di un terzo della casa n. 28. Nel 1900 Filippo e Agostino divisero la sostanza fino allora posseduta in comproprietà che oltre a quanto ereditato dal padre, comprendeva la sopraccitata parte di casa n. 28 e il prato ai Visenzi (p.f. 596 e 597). 1) Filippo, nato nel 1852, abbandonò il maso Widmann per stabilirsi nella casa n. 2 insieme alla moglie Anna Conci di Vervò. In quella stessa abitazione visse fino alla morte, avvenuta nel 1917, anche la sorella Eugenia. Dal matrimonio nacque nel 1890 un’unica figlia, Pia Celestina, che rimase orfana di madre all’età di quattro anni. Nel 1901 Pia fu designata erede di un Conci di Vervò, con ogni probabilità il nonno materno o, forse, uno zio. In seguito emigrò negli Stati Uniti, dove probabilmente si sposò, ma di lei non si ebbero più notizie. Nel 1900 Filippo sposò in
seconde nozze Anna Chistè, figlia di Vittore di Dermulo, dalla quale ebbe un
figlio, Celestino, morto a Pergine nel 1942. Due anni dopo, nel 1902, Anna
ricevette dal padre quasi 400 fiorini, a lei spettanti per l’eredità della
madre. Nello stesso periodo, Filippo risultava debitore nei confronti della
figlia Pia della somma di 347 fiorini, corrispondenti alla quota dotale
spettante alla prima moglie. Per tale somma furono sottoposti a ipoteca
tutti gli stabili pervenuti a Filippo nelle divisioni con il fratello
Agostino. Quindi la metà della casa al n. 2, la metà dell’orto
agli Orti
(p.f. 160), la metà del pascolo e
bosco alla Cros (p.f. 315), la
metà dell’arativo alla Cros (p.f. 316),
la metà divisa a settentrione del prato a
Rizzai (p.f.
555, 556), la metà divisa del prato ai
Visenzi ( 2) Agostino nato nel 1849, sposò Emilia Inama, figlia di Giuseppe Rodar, e passò quasi tutta la sua vita nella casa n. 25, come manente della famiglia Widmann. Dal matrimonio nacquero otto figli: tre di essi – Elena, Maria e Floriano – morirono in giovane età; quattro – Ludovico, Domenico, Silvio e Celestina – emigrarono negli Stati Uniti; solo Emma rimase in paese. Nelle divisioni con il
fratello Filippo, Agostino divenne proprietario dell'altra metà dei terreni
sopra citati. Invece di sua esclusiva proprietà figurava il terreno con
bosco alle Voltoline (p.f. 708,
710). A questo nucleo aggiunse,
nel 1895, un ampio fondo alle Braide
(p.f.
877/3, 878/4, 878/5), acquistato da Mansueta Inama. Poiché Agostino non
riuscì a sostenere i pagamenti, nel 1899 il terreno passò al cugino
Lorenzo
Inama, che saldò al Comune di Vervò i restanti 400 fiorini prestati a suo
tempo ad Agostino. Nel 1906, alla morte di
Matilde Tamè, zia di Agostino, molti beni destinati agli eredi furono
messi all’asta per saldare i debiti contratti con la cassa rurale di Taio.
In quell’occasione Agostino si aggiudicò un bosco alle
Parissole (p.f. 1492)
e un terreno arativo con prato ai Rauti (p.f.
617 e 618). Inoltre, in comproprietà con Costante Tamè, ottenne le quote
indivise di un arativo e prato alle Sorti
(p.f.
766, 767) e di un terreno alle Braide
(p.f.
880, 881). Agostino morì nel 1928 e il cognato
Clemente Inama fu nominato procuratore dei figli di Agostino residenti negli
USA. Il primi figlio a raggiungere gli Stati Uniti fu
Ludovico che lasciò Dermulo nel 1899. Giunto negli USA si
stabilì in Pennsylvania, prima ad Hazleton e poi a East Union nella contea
di Schuylkill. Alla fine del 1901 Ludovico si spostò in Colorado dove nel
1905, a Leadville, prese in moglie Mary Trevison di origini francesi. In
Colorado sicuramente incontrò il mio bisnonno
Candido Inama che, da quanto
esposto in una lettera del 1909 lo aveva aiutato economicamente. Con detta
missiva scritta nel maggio del 1909 a Leadville, Ludovico si scusava per non
aver ancora onorato il suo debito, in quanto, a suo dire, erano diversi mesi
che le cose non andavano bene. Ludovico si spense a Denver nel 1960 quando
era già vedovo da otto anni. Domenico nel 1909 risulta abitare a Leadville in Colorado da dove scrive una lettera al suo amico Candido Inama (fino a circa il 1906 pure lui risiedeva in Colorado) per ringraziarlo per un prestito di cinquanta dollari. In quell'occasione gli comunica che anche suo fratello era lì e che lavorava nella miniera. Il fratello era sicuramente Ludovico. Di Domenico non si hanno altre notizie. Probabilmente morì celibe nei dintorni di Leadville. Silvio che era nato nel 1884, secondo alcuni documenti rinvenuti nell'archivio preunitario del comune di Dermulo, nel 1905 si era imbarcato per raggiungere i fratelli negli USA, ma morì improvvisamente durante la traversata e conseguentemente fu gettato in mare. Invece secondo quanto riportato dal sito www.valdinonusa.com Silvio sarebbe giunto a Leadville nel 1905. Io credo che ci sia stato uno scambio fra Domenico e Silvio, in quanto come provato dalla lettera scritta nel 1909, fu Domenico a raggiungere il fratello Ludovico e non Silvio. Celestina nata nel 1886 aveva seguito i fratelli negli USA ed infatti si era stabilita con loro a Leadville dove aveva conosciuto un emigrato di Romeno, Candido Graiff, con il quale era convolata a nozze nel 1906. Quattro anni dopo rimase vedova e in seguito prese come marito un tale Frank Braderich. Emma nata nel 1887, fu l’unica dei fratelli a rimanere nel paese natio e seguì i genitori nei vari cambi di abitazione. Dai registri comunali risulta che nel 1904 si trovasse a Rovereto assieme a Caterina Tamè, probabilmente come domestica presso una famiglia, anche se non se ne conosce il motivo preciso. Già quattro anni dopo era però rientrata a Dermulo, dove sposò Vigilio Negri di Tres. Quest’ultimo si trasferì quindi a Dermulo, stabilendosi inizialmente nella casa n. 28. Nel 1920 Vigilio gestiva una mescita di vino nella casa n. 35 e, dal 1926, vi affiancò anche la vendita di generi alimentari. Ad Emma pervennero alcuni dei beni che furono del padre Agostino, quali i terreni ai Rauti (p.f. 617 e 618) e alle Braide (p.f. 877/3, 878/4, 878/5). Inoltre, tramite lo zio Clemente, ereditò la casa al Capitel numerata con il 41, abitata dalla famiglia Negri fino alla metà degli anni Settanta del Novecento.
b) GIACOMO, detto Zitol, nacque nel 1818. Nel 1846, in occasione del matrimonio con Barbara Mendini, lasciò la casa paterna e si trasferì al civico 22, immobile di proprietà della moglie. Nel 1855 acquistò dalla cognata Caterina Mendini diversi appezzamenti per la somma complessiva di 260 fiorini. Essi comprendevano: un arativo a Cavauden, un prato alla Pozzata, un arativo e un prato al Plantadiz (p.f. 262), un prato adiacente alla casa e un bosco alla Cros di Santa Giustina (p.f. 280/2). Già l’anno seguente vendette il campo di Cavauden ai fratelli Lorenzo, Pietro e Urbano Inama per 87 fiorini e 45 carantani. Nel 1881 acquisì dallo zio della moglie, Battista Mendini, un ulteriore campo a Cavauden e una porzione di terreno al Plantadiz (p.f. 263), confinante con una sua proprietà. Su questi fondi gravavano tuttavia alcuni oneri: un capitale di 24 fiorini e 22 carantani a favore della chiesa di Dermulo, un’ipoteca di 90 fiorini per un prestito concesso da Michele Ossanna e, sul campo di Cambiel (p.f. 376), un capitale di 87 fiorini e 42 carantani sempre a beneficio della chiesa. Quest’ultimo peso, inizialmente a carico del padre Silvestro, passò successivamente a Giacomo, subentrato nella proprietà. Dal libro d'impianto del catasto, oltre a terreni appena citati, appaiono anche un bosco alle Voltoline (p.f. 714 e 715) e un arativo con bosco al Gomer (p.f. 462, 463 e 467). Dal matrimonio con Barbara nacquero tre figli: Francesco, Silvestro e Rosa (1853). Tutti abitarono nella casa n. 22.
1)
Francesco, primogenito di Giacomo, nacque nel 1847 e nel 1866 sposò
Angela Martinelli, dalla quale ebbe un figlio, Germano,
nato nel 1870. Di Germano si hanno poche notizie: si sa soltanto che emigrò
negli Stati Uniti,
Francesco durante la sua vita incrementò di molto il suo patrimonio. Nel 1880 acquistò da Battista Mendini una parte di casa n. 22, il terreno nei pressi della casa stessa (p.f. 296/1 e 298), un terreno a Rizzai (p.f. 563 e 564), un bosco alla Cros (p.f. 280/2) e il prato alla Busa (p.f. 472). Nel 1891 acquistò dai fratelli Mendini un altro terreno a Rizzai (p.f. 552, 553 e 554) e nel 1903 dagli stessi Mendini un terreno al Raut da Ral (p.f. 20, 21, 27, 28 e 29); nel 1893 Francesco acquisì un terreno alla Caseta (p.f. 531, 532 e 533) a seguito dell'asta indetta per la sostanza di Giovanni Endrizzi; nel 1894 un terreno alle Marzole (p.f. 299) da Pietro Inama; ed infine nel 1903, Francesco ricevette per la quota di legittima materna, un arativo e pascolo a Rizzai (p.f. 559 560 561 562). Non mi è noto quale parte di beni paterni pervennero a Francesco. Nel 1873, Francesco rimase
vedovo, e due anni dopo sposò Teresa Tavonatti di Tavon. Da questa seconda
unione nacquero Virginia (n. 1876), Dei due figli maschi, Giuseppe si sposò per la prima volta nel 1910 con Lucia Pilati, che nel 1911 diede alla luce Primo e, l’anno successivo, Renato, morto però in tenera età. Pochi giorni dopo il parto, anche Lucia venne a mancare. Nel 1914 Giuseppe contrasse un secondo matrimonio con Eugenia Paternoster di Sanzeno, ma poco dopo le nozze — destando grande scandalo per l’epoca — Eugenia abbandonò il marito per far ritorno al paese natale. A Giuseppe era pervenuta gran parte dell’eredità paterna, comprendente, oltre a una porzione della casa n. 22, diversi terreni: alla Ciaseta (p.f. 531, 532 e 533), alle Marzole (p.f. 299) e a Rizzai (p.f. 552, 553 e 554). Con Primo, unico figlio sopravvissuto di Giuseppe, che a sua volta si sposò due volte senza lasciare discendenza, il ceppo familiare si estinse. Fortunato , invece, nel 1903 emigrò negli Stati Uniti, stabilendosi inizialmente a Trinidad, nella contea di Las Animas (Colorado), dove trovò probabilmente impiego nelle miniere di carbone. Poco prima del 1920 si trasferì in Ohio, nella contea di Tuscarawas, quasi certamente su invito del cugino Carlo, residente in quella zona dal 1915. Fortunato sposò Giulia Vit, originaria di Tuenno, dalla quale ebbe cinque figlie: Barbara, Eleanor, Frances, Dorothy e Arline Charlotte. Dal 1940 la famiglia risiedette a New Philadelphia, sempre nella contea di Tuscarawas, dove Giulia si spense nel 1949 e Fortunato (detto Fred) l’anno seguente.
2)
Silvestro
nacque nel 1849 e sposò Maria Tavonatti di Tavon. Dal loro matrimonio
nacquero cinque figli: tre femmine, Barbara, Angela e Giuditta, e due
maschi, Arcangelo e Carlo. Nel 1888 Silvestro decise di emigrare negli Stati
Uniti, lasciando a Dermulo la moglie e i figli ancora piccoli. Non si sa con
certezza in quale Stato si fosse stabilito, ma rimase oltreoceano per almeno
cinque anni. Durante la sua assenza, a causa di un debito di 72 fiorini con
il negoziante Giovanni Fortunato Dalpez di Taio, gli furono pignorati due
terreni, uno al Plantadiz e uno a
Cavauden.
3) Rosa nacque nel 1853 e visse nubile fino alla morte, avvenuta nel 1922, occupando la parte sud-est della casa n. 22. Nel 1903, alla scomparsa del padre Giacomo, divenne unica proprietaria del terreno al Plantadiz (p.f. 263), che donò gratuitamente al Comune di Dermulo, allora impegnato nella ricerca di un’area da destinare al nuovo cimitero. Per questo atto di generosità, Rosa fu riconosciuta come benefattrice della comunità.
2.2.2.2.2. VALENTINO FIGLIO DI BALDASSARRE V. Tav 35
Valentino, il figlio più giovane di Baldassarre, nato nel 1778, ricevette il nome del nonno materno. Da lui ebbero origine quelle famiglie Inama contraddistinte dal soprannome Valentin, oggi ormai estinte. Dal matrimonio, celebrato nel 1827, con Maria Bertolini di Dambel, nacquero ben dieci figli: cinque maschi — Baldassarre, Domenico, Pietro, Lorenzo e Urbano — e cinque femmine — Caterina, Fortunata, Maria, Domenica e Lucia. Baldassarre, Domenico e tutte le figlie, ad eccezione di Caterina, morirono tuttavia in tenera età. La famiglia visse nella porzione C della casa n. 2, che Valentino ereditò dal padre assieme all'orto agli Orti (p.f. 158). (Sul predetto orto nel 1870 la vedova Maria, rappresentante dei figli, assicurò un capitale di 32 fiorini dovuto alla primissaria di Dermulo). Dal padre ereditò anche il terreno al Cambielot (p.f. 377), alle Voltoline (p.f. 708, 709), a Rizzai (p.f. 557 e 558) e un fondo alle Late (p.f. 640). Valentino aveva imparato dal padre l’arte della tessitura, che gli garantì un discreto reddito supplementare. Nel 1833 acquistò dalla chiesa di Dermulo un terreno al Gomer (p.f. 460, 461 e 468) e un altro a Cavauden (p.f. 514/2) per la somma complessiva di 137 fiorini e 33 carantani. I due appezzamenti erano stati da poco ceduti alla chiesa da Giovanni Battista Inama per estinguere un debito. L’anno successivo Valentino morì prematuramente, all’età di soli 46 anni. Il figlio maggiore, Lorenzo, aveva appena quattordici anni, e gli mancavano dunque ancora dieci per raggiungere la maggiore età. Non si hanno notizie precise su come la famiglia riuscì a sostenersi dopo la scomparsa di Valentino. È probabile che la vedova, Maria, in qualità di tutrice dei figli, sia stata aiutata dal cognato Silvestro.
a)
Lorenzo, nacque nel 1820 e sposò nel 1854 Giuditta Zucal di Romeno,
con la quale visse fino agli inzi degli anni Settanta dell'Ottocento in una
parte di
casa n. 28, messagli a disposizione dal cognato
Giovanni Tamè.
Nel 1844, insieme allo zio Silvestro, Lorenzo chiese al conte Leopoldo Thun
il permesso di affrancare il terreno al Gomer, ottenendolo dietro il
pagamento di 50 fiorini. Nello stesso anno iniziò a svolgere l’incarico di
sacrestano, che mantenne per un paio d’anni, per poi riprenderlo nel 1863 e
conservarlo fino al 1881. Lorenzo ricoprì anche il ruolo di Capo Comune dal
1856 fino a maggio del 1861 e fu pure nominato tutore dei minori Giovanni e
Carlo fu Pietro Endrizzi. Nel 1857 acquisì da Lucia
vedova di Antonio Battisti un arativo a
Campolongo (p.f.
820). Nello stesso anno su detto terreno veniva assicurato un capitale
di 46:64 fiorini abusivi verso il fondo primissariale. A Lorenzo toccò: un arativo al Cambiel (p.f. 377), arativo al Blaum (p.f. 426), arativo a Cavauden (p.f. 514/1), bosco alle Sorti (detto anche Plazzec) (p.f. 746), prato alle Voltoline (p.f. 708), bosco alla Cros (p.f. 343), arativo e prato alle Braide (p.f. 877/1, 877/2, 877/4), vigneto al Campolongo (p.f. 820), prato ai Regai pertinenze di Banco e porzione II del prato ai Regai. Nel documento di divisione non si trova stranamente elencato il terreno a Campovecchio (p.f. 540), e di ciò non so spiegarmi il motivo, perchè di fatto era sicuramente appartenuto a Lorenzo e dopo ai suoi figli Demetrio e Fiorenzo. Nel 1872, Lorenzo acquistò da don Giacomo Mendini la casa detta al Capitel (n. civico 23), con orto a sera e cortile a mezzogiorno, per 611 fiorini austriaci. In quella casa si trasferì con la moglie Giuditta e i figli Demetrio, Fiorenzo, Angela, Anna, Addolorata e Virgnia Augusta, stabilendovi la loro dimora definitiva. Fiorenzo
(n. 1859) emigrò in America intorno al 1902 insieme alla sorella Anna. Morì
circa nel 1910. Di lui si conosce poco: secondo quanto raccontato da Mario
Kaisermann, suo pronipote, durante le sue peregrinazioni avventurose entrò
in contatto con popolazioni indigene americane. Alla sua morte lasciò una
cospicua eredità, che la sorella Anna devolse a un convento dell’Istria.
Verso il 1907 Fiorenzo inviò a Dermulo il denaro Anna (n. 1861) fu maestra elementare e insegnò a Dermulo negli anni 1880/81, 1890, 1922 e 1925. Nel 1902 emigrò in America con il fratello Fiorenzo, ma successivamente fece ritorno in paese. Non si hanno notizie certe di eventuali altri incarichi d’insegnamento in altre località. Angela (n. 1866) sposò nel 1893 Giuseppe Kaisermann di Mezzolombardo. Il loro figlio Germano, sposando Ida Inama, si trasferì a Dermulo. Addolorata (n. 1863) e Augusta (n. 1868) abbracciarono la vita religiosa; della prima si sa soltanto che era conosciuta come suor Abene. Demetrio (n. 1855) sposò Maria Zambiasi di Taio. La coppia visse per un breve periodo a Taio, a partire dal 1904, per poi tornare a Dermulo nella casa paterna n. 23. (Nel 1894 il padre Lorenzo gli aveva trasferito metà della casa.) Nel 1926 Demetrio fu nominato procuratore dei figli minori di Domenico Tamè, residenti negli Stati Uniti. Dal matrimonio non nacquero figli e, negli anni Quaranta del Novecento, il consistente patrimonio di famiglia passò in gran parte a Domenico Zanon di Rabbi.
b) Pietro, nacque nel 1822 e nel 1869 sposò Maria Melchiori, probabilmente originaria di Tuenetto. La coppia abitò nella porzione C della casa n. 2, acquistata dal nonno Baldassarre dalle sorelle Anna e Dorotea Inama. Nel 1871 Maria diede alla luce l'unica figlia, Mansueta. Nel 1879, con il marito ancora in vita, Maria acquistò da Teresa Mendini, moglie di Pietro Inama detto “Guslot”, un terreno arativo al Cambiel (p.f. 337 e 338), confinante a nord con una proprietà che Pietro possedeva assieme con i fratelli. È probabile che, dopo la morte della madre, questo campo sia stato venduto da Mansueta al cugino Demetrio. Dalle fonti d’archivio comunali risulta che Pietro non intratteneva buoni rapporti con Giacomo Endrizzi. Nel 1878 quest’ultimo presentò infatti una segnalazione al capocomune, lamentando che Pietro aveva malmenato e coperto di “varie infamie” il figlio. Non sembra tuttavia che vi siano state conseguenze rilevanti, se non forse un semplice ammonimento verbale. Nel 1880, in seguito alle divisioni ereditarie, Pietro entrò in possesso esclusivo di diversi beni: la casa n. 2, con cortile allo scoperto, l’orto (p.f. 158/1), un arativo con bosco detto al Gomer (p.f. 460, 461 e 468), un arativo al Raut (p.f. 640), un arativo a Rizzai (p.f. 557 e 558), un bosco al Blaum (p.f. 420), un vignale a Campolongo (p.f. 826 e 827), un arativo e prato alle Braide (p.f. 878/4 e 878/5), un arativo alle Braide (p.f. 877/3), un prato ai Regai, pertinenze di Banco, e una porzione di un altro prato nella stessa località. Il valore complessivo dei beni assegnati ammontava a circa 745 fiorini e 50 centesimi, a fronte di un terzo dei capitali passivi pari a 162 fiorini e 78 centesimi. Nel 1882 Pietro aggiunse ai beni sopra elencati, un terreno alle Marzole, ossia al Poch (p.f. 300/2), acquistato dalla famiglia Eccher per 40 fiorini. Nel 1893 lo stesso terreno fu poi venduto a Camillo Inama per 130 fiorini. Pietro morì nel marzo del 1891; la moglie gli sopravvisse almeno fino ai primi anni del Novecento. Dopo la morte del padre, Mansueta, assistita dal marito Placido Tait di Mezzolombardo (che aveva sposato nel 1891), mise in vendita tutti i beni di famiglia. Nel 1892 vendette il vigneto di Campolongo (p.f. 826 e 827) a Eugenio Inama per 140 fiorini; nel 1893 cedette il terreno al Raut (alle Late) (p.f. 640) ad Andrea Eccher e un prato ai Regai, sul territorio di Sanzeno (p.f. 448), a Costante Tamè. Nel 1895 alienò il terreno alle Braide ad Agostino Inama, nel 1897 vendette al cugino Demetrio il bosco al Blaum (p.f. 420) e nel 1899 cedette la porzione C della casa n. 2 e l’orto (p.f. 158/2) ai fratelli Celeste e Annibale Inama per 383 fiorini. Nella casa abitava ancora la madre di Mansueta, Maria, che conservava il diritto di usufrutto sull’abitazione; per questo motivo parte del prezzo fu versata solo dopo la sua morte. Non si hanno invece notizie certe sulla sorte dei terreni situati a Rizzai (p.f. 557 e 558), al Gomer (p.f. 460, 461 e 468) e del bosco a Mollaro (p.f. 544).
c) Urbano, nacque nel 1830 e intorno al 1872 sposò Erminia Calliari di Romeno. La coppia, ormai non più giovane, ebbe un figlio maschio nel 1873 e due gemelle nel 1876, tutti deceduti poco dopo la nascita. Nel 1880 nacque invece Giovanni Albino, che rimase orfano di padre a due anni e morì ventenne nel 1900. Urbano visse con la famiglia nella porzione A della casa n. 3, assegnatagli nel 1880 durante la divisione dei beni con i fratelli. L’abitazione passò poi al figlio Albino e, dopo la sua morte nel 1901, alla madre Maria, la quale nel 1903 la vendette — insieme all’orto (p.f. 158/2) — a Ottilia, moglie di Modesto Inama. Nelle divisioni del 1880 a
Urbano furono inoltre assegnati i seguenti terreni: un arativo alle
Fontanele, nelle pertinenze di Coredo; un bosco alle
Parissole; un arativo
alla Cros (p.f. 317); un arativo
a Cavauden; un bosco a
Lamport (p.f. 273 e 274); un bosco e prato
alle Voltoline (p.f. 709, 713, 716);
un arativo, prativo e vignato alle Braide
(p.f.
878/1, 878/2,
878/3); un prato alle
Braide (p.f.
877/4); un prato ai Regai, pertinenze di Banco, e un’ulteriore porzione
di prato ai Regai. Il valore complessivo dei beni assegnati a Urbano ammontava a 745 fiorini e 50 centesimi, a cui si aggiungeva un terzo dei capitali passivi, pari a 162 fiorini e 78 centesimi.
d) Caterina nacque nel 1833 e nel 1851 sposò Giovanni figlio di Vittore Tamè di Dermulo. Giovanni, suo malgrado, fu coinvolto nei due fatti criminosi avvenuti a Dermulo nel 1858: possiamo solo immaginare l’apprensione che lei e la sua famiglia dovettero provare in quei momenti. Caterina morì a Dermulo nel 1877.
2.2.2.3. VITTORE FIGLIO DI OTTAVIO
Di Vittore, figlio maggiore di Ottavio, nato nel 1703, si hanno poche notizie. La formula “Vittore fu Ottavio Inama” compare assai di rado nei numerosi documenti esaminati, in netto contrasto con la ricorrenza ben più frequente del nome del fratello “Giacomo fu Ottavio Inama”. È probabile che Vittore si sia trasferito precocemente a Taio, dove infatti lo si trova già nel 1731, citato tra i testimoni presenti alla stesura del testamento di don Pietro Panizza. Non è noto se in quel periodo ricoprisse già l’incarico di masadore dei conti Thun o se tale mansione sia stata assunta solo in seguito. All'epoca, comunque, il cugino Giovanni Giacomo II svolgeva il medesimo ruolo presso il maso di Castel Bragher. Nel 1738 appare in un documento come testimone nel seguente modo: "Vittore figlio di Ottavio Inama di Dermulo, abitante a Taio"; nel 1742 figura tra gli iscritti alla confraternita del Santissimo Sacramento di Taio; nel 1749 è citato come testimone nella redazione di un contratto di locazione stipulato a Taio tra il fratello Giacomo e Giacomo Antonio Inama. L’anno successivo compare anche nell’elenco ufficiale degli abitanti del paese. Per quanto riguarda il patrimonio, i beni di proprietà risultano molto pochi. Nel 1751 è menzionato come confinante di un terreno nella zona di Cambiel alle Spinate, mentre nel 1754 si registra l’unico acquisto noto: un terreno a Cavauden (porzioni 6 e 7 della p.f. 610 sul comune catastale di Sanzeno), comprato da Floriano Inama e don Gaspare Chilovi. Nel luglio del 1731 Vittore sposò Anna Chini, figlia del fu Martino Chini di Segno, per cui Francesco, fratello della sposa, costituì la dote con 190 ragnesi dai quali vennero defalcati il valore del letto e vestiti. Francesco si impegnò a versare il rimanente importo, in varie rate annuali di 30 ragnesi ciascuna "in grano interzato alla tassa oppure bestiame bovino o vino". Dal matrimonio nacquero due figlie, alle quali furono dati i nomi delle rispettive nonne: Cecilia, in onore di quella materna, e Lucia, di quella paterna. Nel 1752, in occasione delle promesse di matrimonio tra Lucia e Giovanni Battista Inama di Dermulo, il padre le destinò una dote di 200 ragnesi, precisando che, qualora fosse morto senza figli maschi, Lucia avrebbe dovuto dividere l’eredità con la sorella Cecilia. Nel 1759 la secondogenita Cecilia contrasse matrimonio con Giovanni Inama, fratello del cognato Giovanni Battista. In tale occasione Vittore le assegnò la stessa somma già elargita alla sorella, pari a 200 ragnesi. Alla fine di quello stesso anno egli comparve come testimone alla redazione del testamento di don Filippo Panizza. Nel 1763 Vittore decise di affidare la conduzione del maso Thun al genero Giovanni Inama. Il contratto prevedeva una durata di nove anni e un canone annuo di 90 troni, comprendendo nella locazione anche un campo a Vin, nelle pertinenze di Taio. Tra le condizioni vi era l’obbligo per Giovanni di accollarsi un debito di 900 troni del suocero, derivante da affitti non pagati, nonché di trasportare il primo e il secondo fieno dalla località Saegen. In cambio, Vittore gli trasferì “tutti i mobili che teneva in casa, le fruggi raccolte e pendenti, il grano e brascato, il letame e l’utile sopra i bovi”. Poiché tempo prima Vittore aveva donato all’altro genero, Giovanni Battista, 50 ragnesi, stabilì che Giovanni potesse appropriarsi di una parte della casa di Taio per un valore equivalente. Intorno al 1769 Vittore morì. Le due figlie, Lucia e Cecilia, decisero di vendere la casa paterna a Taio — situata nel colomello ai Faroni — a Pietro Antonio Panizza. Nelle divisioni ereditarie con i fratelli Giacomo III e Silvestro IV, Vittore era inoltre entrato in possesso di una parte di casa a Dermulo, ossia la porzione C della casa alla Crosara, con il relativo orto (p.f. 162). Tale porzione, in seguito suddivisa tra le due sorelle, pervenne poi a Cecilia, la cui figlia Anna la cedette nel 1801 a Giuseppe Inama. La casa alla Crosara è così descritta: “Una bottega a revolto tramezzato, la comunione del portico e della scala per salire in alto e anche della saletta, la cucina vecchia intera, la stua d’appresso, un andito ossia saletta di sopra indivisa con Silvestro Inama, col coperto da mantenersi dal cognato Giovanni interamente, con la parte di somasso e di stradughe e coperto fino all’aria. Ancora un andito sopra il revolto di Giacomo fu Ottavio Inama col coperto fino all’aria.” Ad eccezione delle due case — una a Taio e una a Dermulo — dell'orto agli Orti (p.f. 162), dei terreni a Cavauden (p.f. 521) e p.f. 610, di un bosco a Cambiel (p.f. 392 e 393), di un terreno al Gomer (p.f. 460, 461 e 468) e di un altro alle Fontanele, non risultano altri beni intestati a Vittore. Pur non potendosi escludere, in assenza di un catasto coevo, l’esistenza di ulteriori proprietà non documentate, resta difficile comprendere come egli, pur essendo il primogenito, abbia ereditato così pochi beni paterni. Dopo la morte di Vittore quindi, tali beni rimasero alla famiglia Inama, passando però ai discendenti della linea di Gaspare.
[1] Questi spostamenti erano dovuti principalmente all’esercizio del notariato. [2] Antonio nel 1475 possiede dei beni a Fondo, fra i quali la casa. I suoi due figli Nicolò e Tommaso avevano ricevuto il 25 aprile 1516 dall’imperatore Massimiliano lo stemma, che il vescovo Bernardo il 24 giugno 1530 conferma ai due fratelli e ad essi conferisce la dignità di nobili vescovili per i servigi da loro resi durante la sollevazione dei rustici. (Carl Ausserer in “Der Adel des Nonsberges”) (Gli attuali Inama di Coredo sono i discendenti di Nicolò.) [3] Da Sarnonico poi una persona si trasferì a Sanzeno, dando origine ad una numerosissima discendenza ivi ancora presente. Qualche membro delle famiglie Inama di Sarnonico e Ronzone si portò a Caldaro ed in altri paesi della valle dell’Adige da qui poi in Tirolo e Vorarlberg [4] A Lavis troviamo nel 1486 un certo Nicolò Inama di Dermulo, conduttore di un albergo-osteria denominato “alla Stella”. Tale casa gli fu concessa in affitto dai procuratori della chiesa di Pressano e rimase degli Inama fino ai primi anni del Settecento. (V. Albino Casetti Storia di Lavis Giurisdizione di Königsberg-Montereale pag. 250) [5] Odorico, nipote di Michele, era Cavaliere dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto anche Ordine di Malta. Di lui si trova ricordo anche al santuario di S. Romedio, dove è presente un quadro ex voto che lo raffigura. Odorico è menzionato molte volte nei rogiti notarili del notaio Antonio Inama di Coredo. [6] Gli odierni Inama di Taio (Rodari), sono i discendenti di Giovanni spostatosi a Taio all’inizio dell’Ottocento, in qualità di “masadore” a Castel Bragher. [7] Prima di lui era giunto a Favogna lo zio Antonio, senza però lasciare discendenza. [8] Sono state tradotti dal libro “Geschischte aller Familien Inama” di Hanns Inama Sternegg, solamente le sezioni ed i paragrafi concernenti gli Inama che abitarono a Dermulo. Le varie tavole sono state compilate tenendo conto anche delle nuove notizie emerse durante le mie ricerche. [9] Per questo capitolo fatta eccezione ai paragrafi : 1.1.2.1., 1.1.2.1.1., 1.1.2.2., mi sono avvalso della traduzione del capitolo Quarto (da pag. 169 a pag 176) del libro “Geschichte aller Familien Inama” gentilmente effettuata dal dott. Amadio Chilovi. Le mie integrazioni, compaiono invece fra parentesi quadre, in colore fucsia. [10] Lo Sternegg però lascia viva l’ipotesi che il Marino capostipite delle famiglie Inama con soprannome Fogia, fosse proprio questo, (figlio di Valentino) e non il Marino figlio di Antonio. Questa supposizione è stata poi smentita con l’acquisizione di altre recenti notizie. [11] Cfr. Endrici Edoardo “Coredo nell’Anaunia” pag. 24. [12] Un figlio di questo Leonardo, ritornerà in seguito a Dermulo (con il cognome Endrizzi) e darà origine ad una discendenza che si estinguerà nel Settecento. (V. Le famiglie Endrizzi) [13] Non è da escludere che l’Antonio figlio di Giovanni, considerato dall’Inama-Sternegg come un discendente di Antonio Inama figlio di Nicolò da Fondo, non sia invece l’Antonio figlio di Giovanni figlio di Gaspare. Probabilmente Giovanni abitava a Coredo ed è per questo che alla sua morte, il figlio Francesco fu posto sotto tutela di Gabriele Barbi. In un documento rogato a Coredo il 16 aprile 1608 si firma: Ego Antonius fq. Dns Jovannis de Inamis de Her.lo convicinus et incola Coredi….. [14] Libro dei matrimoni della parrocchia di Coredo. [15] AST Atti del notaio Giovanni Michele Widmann di Coredo Busta I anno 1670. [16] Notizia comunicatami da Maurizio Erlicher di Coredo. [17] Karl Inama-Sternegg riporta nel suo manoscritto che la moglie di Valentino era una certa Caterina “de Husenim”. Dal registro parrocchiale dei matrimoni invece, si evince che il nome è Cristina Geronimi. Il cognome in verità appare come “Hieronimis de Villa ac Plebe Revodiana”, e pertanto è stato letto come “de Husenim” come pure il nome Cristina, letto Caterina. Ritengo comunque che l'autore abbia fatto molta confusione con il nostro Valentino, forse scambiato con l’omonimo figlio di Marino, pure sua figlia Maddalena appare figlia del fratello Antonio. [18] Ciò si deduce da un atto notarile del 1722, dove Antonio vendeva al fratello Gio.Batta la sua parte di casa. [19] Hanns Inama-Sternegg nella sua già citata opera, ha ripreso molte notizie dal libro manoscritto dello zio Karl, in certi casi molto impreciso. In questa occasione, Karl Inama-Sternegg aveva scambiato Gio.Batta di Bartolomeo, con Gio.Batta di Gio.Batta, e aveva attribuito quindi al primo, la discendenza di questo ramo Inama estintosi a Dermulo alla fine del secolo scorso. Nella tavola III (Der Stamm des Gasparus) inoltre, si può notare che una certa Cecilia sposava nel 1760 in seconde nozze il vedovo Gio.Batta fu Bartolomeo. La Cecilia in questione era la figlia di Vittore Inama (V. Tav.33), maritata nel 1759, non con Gio.Batta fu Bartolomeo, ma con Giovanni fu Gio.Batta. (V. Tav. 28) [20] Quindi senza interruzione dal 1717 al 1737 e poi forse dal 1747 fino al 1757 anno della sua morte. [21] Nel manoscritto di Karl Inama-Sternegg si trovano le date di nascita dei tre fratelli così come riportate nella Tav. 28. Antonio però non poteva essere nato nel 1732, perché sposandosi nel 1745 avrebbe avuto solo 13 anni. La sua data di nascita è da collocare intorno al 1720. I suoi genitori si era sposati nel 1716 e ritengo che Antonio fosse il più vecchio fra i tre fratelli. [22] Hanns Inama Sternegg, considerando che questo ramo Inama si era estinto alla fine del secolo XIX, non si è premurato di fornire date e notizie in ugual misura degli altri ceppi. Da parte mia nell’affrontare il lavoro di stesura genealogica delle famiglie di Dermulo, avevo dato per scontato tutto quello che riguardava gli Inama. Salvo poi dovermi ricredere constatando la parziale o totale mancanza di notizie riguardo ai discendenti di Valentino Inama, di Giacomo Antonio Inama e di Gio.Batta Inama. A questo punto però avendo già ultimato il lavoro di consultazione dei vari libri parrocchiali per gli altri cognomi, non potevo certo ricominciare daccapo per gli Inama, ecco quindi spiegato le tante date mancanti o approssimate. [23] Sicuramente esercitò il servizio di mammana cioè levatrice, dal 1815 al 1821. [24] Secondo Karl Inama-Sternegg, Giovanni rimasto vedovo di Cecilia sposa in seconde nozze una certa Agnese Clauser. [25] Gio.Batta ricoprirà la carica di Sindaco della chiesa nel 1751, quando arrivarono in paese, per le periodiche rilevazione, i visitatori vescovili. [26] Elisabetta Teresa figlia di Gio.Batta IV°, sposerà Camillo Inama figlio di Giacomo Sèp, che dal suocero erediterà oltre alla casa, anche il soprannome Batistei. [27] Nel 1766 Gaspare e Giacomo sono beneficiati di un prato alle Longhe dai loro cugini Gregorio e Giorgio Endrizzi di Mezzocorona [28] Nel manoscritto di Karl Inama-Sternegg viene menzionato come figlio di Giacomo un certo Gio.Batta del quale io non ho mai trovato notizie. Sicuramente si trattava di un altro dei numerosi Giacomo presenti nella famiglia Inama. [29] Come detto nel paragrafo 2.2.2.2., probabilmente questo Antonio è stato considerato dall’Inama Sternegg come figlio di Silvestro fu Ottavio. [30] Presumo si trattasse di un “faméi”, cioè un famiglio. [31] Documento presso Alessandro Emer di Taio. [32] Secondo l’Inama Sternegg, Pietro era sposato con Marianna Sicher di Coredo ed era morto nel 1816. Si tratta però di un errore poiché sicuramente il Pietro sposato con Marianna era figlio di Giovanni Francesco, e non di Giovanni Michele. [33] Di questo soprannome che sembra risalire addirittura al XIV secolo, non ho mai trovato cenno nei documenti settecenteschi consultati. Si trova invece citato alla fine dell’Ottocento. [34] Per questa parte, mi sono avvalso della traduzione del capitolo Quinto (da pag. 189 a pag 210) del libro “Geschichte aller Familien Inama” gentilmente effettuata dal dott. Amadio Chilovi. Fanno eccezione i paragrafi 2.2.1.1.1., 2.2.1.1.2., 2.2.1.1.3., 2.2.1.1.4., 2.2.2.1.1., 2.2.2.1.2., 2.2.2.2.1. e 2.2.2.2.2 compilati dal sottoscritto. [35] Fra le persone che nel Cinquecento portavano il nome Rigolo, c’era anche un componente della famiglia Mendini, che sicuramente veniva chiamato anche Gregorio. La figlia Anna, era andata in moglie a Leonardo Endrizzi di Don ed il loro figlio fu chiamato Gregorio. [36] Non si capisce da dove scaturisca “S. Maria”, visto che la chiesa era dedicata ai SS. Filippo e Giacomo, anche se in antico appariva solo S. Giacomo. Santa Maria compare stranamente anche sulle mappe catastali di metà ottocento, nella zona sottostante la vecchia chiesa. L’unica spiegazione plausibile per il toponimo, finchè altri documenti non la smentiscano, è che i terreni appartenessero alla Chiesa di S. Maria di Taio. [37] “Fu nominato monaco del chiostro sui monti di Sfruz, Smarano e Coredo e di Castel Brughier dove si occupò dell’impianto e della tenuta dell’archivio…” Frase abbastanza ardua da interpretare! [38] Un nipote di Michele di nome Odorico era Cavaliere dell’Ordine di Malta. [39] Il notaio Gottardo de Gottardi operava a Rallo. [40] Di quale casa si trattasse si possono solo fare delle ipotesi, e cioè o una parte della futura casa n. 2/3 o la casa n. 7 - 8. In ogni modo la casa fu venduta dai Pangrazzi o dai loro eredi nell’arco di breve tempo. [41] L’anno di inizio delle registrazioni parrocchiali a Taio è il 1616 per il libro dei nati e battezzati, il 1612 per i morti e il 1668 per il libro dei matrimoni. Esiste poi una busta contenente un registro di matrimoni antecedenti il 1668 che però si presenta lacero e quasi illeggibile. [42] Sullo stipite del portale della casa ex n. 27 si puo ancora oggi leggere la data 1628 e le iniziali “V I”. [43] Domenica era figlia di Paolo Endrizzi di Caltron ed il matrimonio era avvenuto nel 1686. [44] L’Inama Sternegg nel suo libro dice che “Pietro visse da scapolo a Dermulo fino alla sua morte avvenuta nel 1848” ma sicuramente il Pietro Inama che visse scapolo era figlio di Giovanni Michele Inama. A sostegno di tale evidenza oltre a trovare per ben due volte il nome Giovanni Francesco nella figliolanza di Pietro (una nel 1800 l’altra nel 1805) che quindi com’era di consuetudine riprendeva il nome del nonno, esistono diversi documenti presso archivi privati di Dermulo. [45] Fortunata, mentre si trovava dietro l’uscio della sua casa, fu colpita da una pallottola sparata da un soldato tedesco nel mese di maggio del 1945. [46] Dagli altri cinque figli (Domenico, Giovanni, Pietro, Nicolò e Francesco) tutti sposati e abitanti a Taio, Giovanni ebbe il considerevole numero di 50 nipoti. [47] Non sono riuscito a reperire altre notizie sull’attività di Luigi, dall’unico documento che ne accenna, non traspare se si trattava di un vero e proprio negozio o solo di commercio ambulante. [48] Dal matrimonio non risulta siano nati dei figli, e comunque se ciò non fosse vero, nessuno è sopravvissuto a lungo. [49] Geremia possedeva anche il cosi detto stabbio numerato poi con il 32, oggi abitazione di Aldo Sandri. [50] La parte di casa n. 5 era presumibilmente quella lasciata libera da Giuseppe Inama Bomba, dopo il suo trasferimento nella casa n. 26. [51] Su Maria Bertagnolli esistono notizie contrastanti sul luogo e la data di morte: in un atto comunale del 1917 si menziona Maria Bertagnolli moglie di Emanuele Inama nata nel 1880 e morta a Romitz in Boemia il 23.3.1917. In un altro atto del 1927 si ribadisce: Maria Inama morta a Bonhice in Boemia il 23.3.1917. Infine si trova pure un documento dove si dice che Maria è morta a Pergine nel 1918. [52] Anche Angelo partirà per gli USA, ma tornerà molto presto. [53] Si trattava della porzione di casa che si incontrava immediatamente a destra appena arrivati sul “somas”. [54] Questo mi fu riferito da Giuseppina Inama figlia ancora vivente di Romedio. I cosiddetti bordanti erano operai che essendo scapoli o non avendo al seguito la moglie si affidavano a famiglie di paesani che dietro un discreto compenso provvedevano alle loro cure. [55] Il matrimonio si è celebrato in Colorado, dove Assunta assieme ai suoi fratelli gestiva un “saloon”. [56] Nel 1910 era ancora negli U.S.A. [58] Erroneamente Karl Inama riporta che Giovanni Battista era un figlio di Giacomo fu Michele, anziché di Giacomo fu Ottavio. [61] L'atto processuale da cui ho tratto le informazioni era stato reperito nel web molti anni orsono ma al tempo non avevo segnato l'indirizzo URL. Oggi (2025) pur effetuando varie ricerche la risorsa è risultata non è più disponibile. [62] Questo Antonio, secondo me, potrebbe essere stato scambiato con il figlio di altro Silvestro Inama, detto “Salà”. Avendo sott’occhio una copia dell’albero genealogico delle famiglie Inama, mi viene da pensare che l’autore vi abbia attinto per certe notizie per cui non avesse la possibilità di altro riscontro. Tale genealogia alla luce di molti documenti da me consultati contiene qualche imprecisione. |